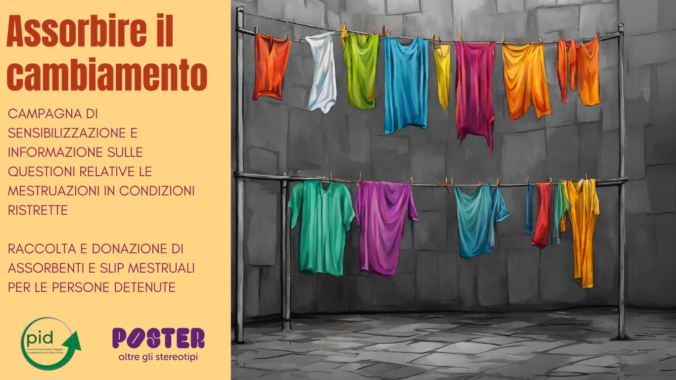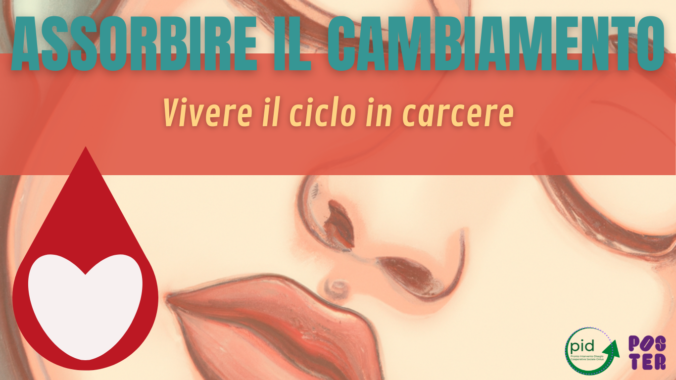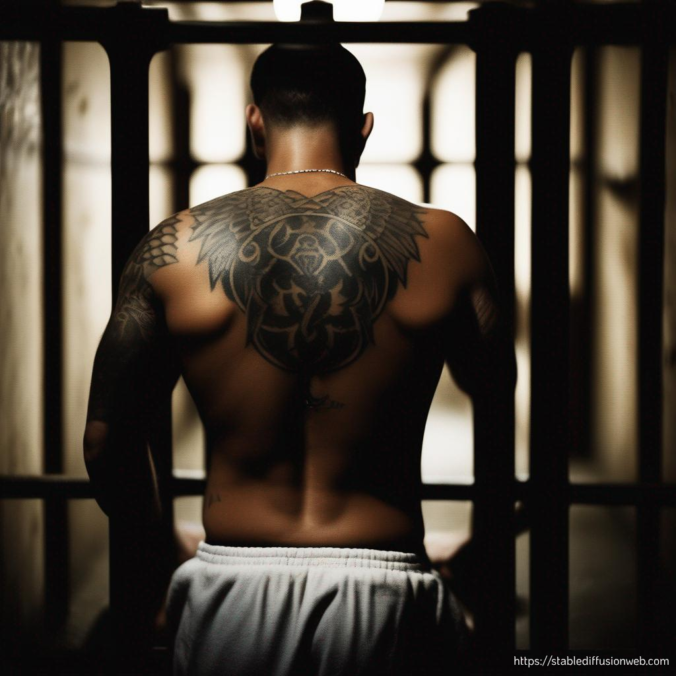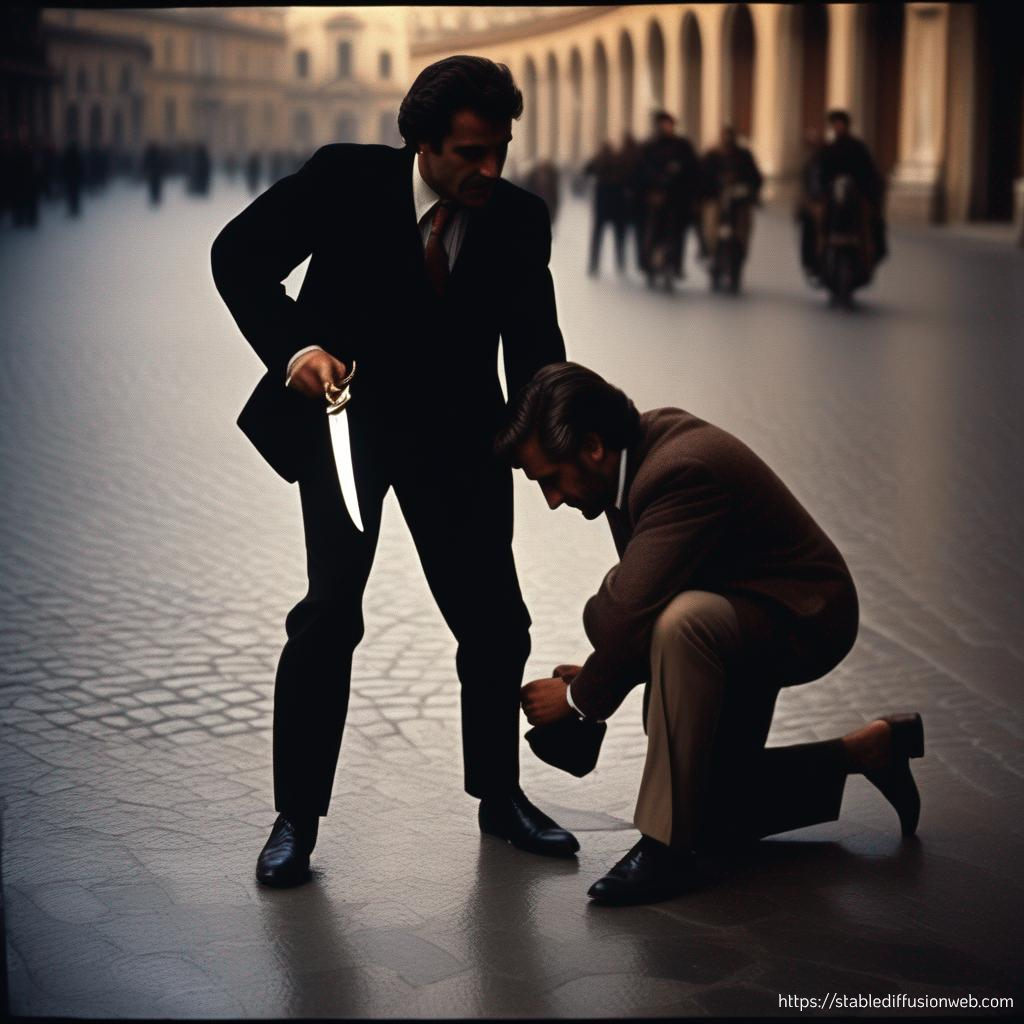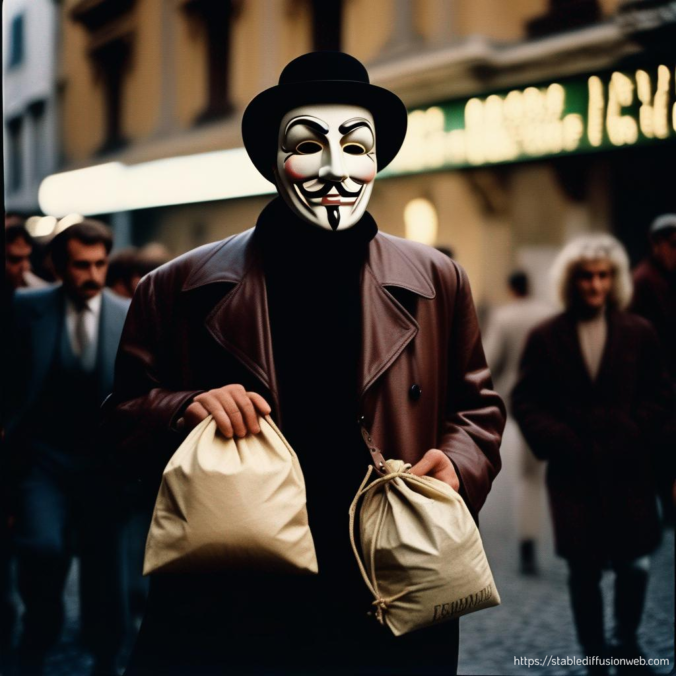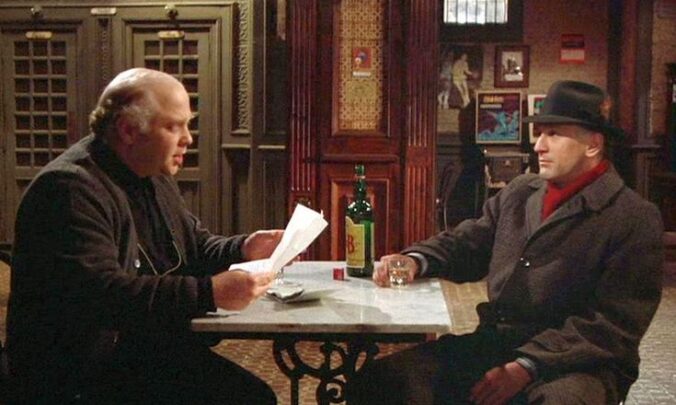Un ricordo recente, quello di Rosaria, una signora di 52 anni ospite all’interno di una struttura di accoglienza romana per persone detenute in misura penale esterna o ex detenute. Abbiamo incontrato Rosaria quasi un mese fa e ha partecipato volentieri al progetto Assorbire il cambiamento che – come ormai saprete – prevede oltre alla donazione di assorbenti per il carcere e le persone detenute nelle strutture di accoglienza, questa raccolta di preziose testimonianze che ci rendono possibile andare oltre le alte mura degli istituti penitenziari e ascoltare, o in questo caso leggere, come vivono il ciclo mestruale le persone ristrette.
Qualche tempo fa sui nostri canali social già abbiamo letto una piccola parte dell’intervista fatta a Rosaria:
«Chi prende terapia gli scende proprio che è ‘na bellezza eh, per gli anticoagulanti. Dicevano “mamma mia c’ho tutto sto ciclo”, queste se spaventavano… Perché non sapevano, erano ignare. Poi se fai uso di dr0g4, ehhh! Se fai quello ti si riduce, e tante lo fanno pure per questo, perché non sopportano … e invece quando vengono monitorate con la terapia, tutto ‘sto sangue … Tante dovevano cambiare spesso le lenzuola perché avevano ‘sto problema. E quindi c’è chi soffre di più e chi di meno.»
E ancora, riguardo ai farmaci:
«Io per esempio sono stata una che quando sono entrata (47 anni nel 2019) avevo il flusso abbondante, ce l’ho sempre avuto abbondante e prendevo una medicina a base di penicillina. Un antinfiammatorio buono per le ossa, per il mal di schiena e pure perché riduce il flusso mestruale. […] Poi me s’è regolarizzato molto con la maternità e non l’ho preso più. Lì me davano… quello che avevano. Brufen, Oki, Buscofen … E io me prendevo quello che potevo insomma, quello che tolleravo insomma perché l’oki non lo tollero, me se mette sullo stomaco. Poi una volta, non riuscendo con questi […] mi diedero l’Ugurol che è un riduttore, so goccette che te danno. ‘Na volta, due, tre e quello me disse, l’infermiere che stava là, “ma che stai andà in menopausa?”. “No io so proprio così” – gli ho fatto – “C’ho la mia medicina che mi dovrei far prescrivere”. Dice “Ok” e quindi me diede sta cosa qua.»
Oggi riporteremo il più fedelmente possibile, il suo racconto riguardo:
- Il ruolo da spesina in carcere – la farmacia;
- “La gioia nel cuore” delle persone detenute per le donazioni ricevute;
- Richiedere le visite specialistiche in condizioni ristrette.
ROSARIA
Il ruolo da spesina in carcere – la farmacia
Allora, io vi posso assicurare – dato che ho fatto la spesina per tre anni all’interno della sezione *** – davano 1 pacchetto o al massimo 2 pacchetti di assorbenti a detenuta, quando avevano la possibilità, altrimenti si compravano. Venivano da me e li acquistavano.
A. «Quindi al sopravvitto?»
Sì, tante richiedevano gli assorbenti perché stavano più comode, rispetto a quelli che passavano. Poi, da me prendevano quelli interni, i tampax, ci stavano i regular e quelli più abbondanti.
A. «E a livello di costi?»
Eh, dei costi… dovrei pure avere la lista da parte. Comunque… costicchiavano. Stavano dai 3 euro in su, alcuni pure molto di più. Mo’ non vorrei esagera’, non me ricordo esattamente l’importo, però quello era. E quindi apprezzavano quando glieli donavano, tante volte andavano a chiedere pure alle suore, chiedevano alle associazioni… è normale. Perché poi c’erano quelle che stavano col flusso abbondante, chiaramente.
Quando c’era la farmacia, alla prima e alla terza settimana del mese – ancora me ricordo – si facevano le domandine per i farmaci – su richiesta poi della dottoressa o del dottore che ti doveva mettere in visita a seconda del giorno del piano in cui stavi. Ti facevano la prescrizione, la visita, quello che è. Però insomma si dovevano imporre, ad esempio se volevano una specifica medicina, dicevano:“No, perché io lo so che questo qua lo usavo già da fuori, me va bene e voglio questo qua non voglio cambia’”. Allora arrivava questa medicina. Le pagavano a loro spese.
Se invece dovevano farsi portare le medicine dai parenti, da fuori, dovevano fare ulteriori richieste per farle entra’ e tutto quanto.
Ne facevo tante. Molte chiedevano le vitamine, chiedevano il multicentrum e soprattutto le ragazze nere se sentivano scoperte, non coperte, poco tutelate.
Tutte, tutte se lamentano, chi pe’ na cosa, chi pe’ n’altra.
“La gioia nel cuore” delle persone detenute per le donazioni ricevute
Vi dirò di più: quando venivano co’ i carrelli perché le associazioni, come Sant’Egidio, mandavano che ne so, du pacchetti di caffè coi biscotti… I biscotti di quelli che dentro non ce stanno, tipo batticuore, pandistelle… C’era una felicità immensa che sembrava chissà che cosa avevano ricevuto. C’era una gioia veramente nel cuore.
Te portavano tante cose, anche i reggiseni magari di un colore differente a quello che avresti voluto ma il modello quello è. Le pantofole, io ancora ho quelle di S.E., è ‘na gioia immensa… Partiva lo scambio, “A te de che colore te l’hanno dato?”. Addirittura tanti fanno i pacchi, li mandano in uscita per i propri parenti, per i nipoti, per i figli. Hanno portato, mi ricordo, le magliette della Lazio, della Roma, le tute quelle svasate fatte a campana, i pigiami… Tutte contente, tutte entusiaste, quindi sposano bene l’idea. Non se sentono abbandonate, dicono “Ah menomale c’è qualcuno che ce pensa.” E quindi sono contente di questo.
A. «Certo, e le donazioni di assorbenti invece, sono mai arrivate?»
Sì. Vengono, vengono. Fanno delle consegne a parte magari, quando l’assistente lo richiede, perché a volte è successo che mettono dentro anche spazzolini, dentifricio, i prodotti igienici diciamo. Li mettono dentro una saletta e poi quando decidono li consegnano.
Volevo di’, del fatto degli assorbenti, in genere li consegnavano col cambio delle lenzuola, il martedì se faceva il cambio delle lenzuola ‘na volta a settimana. Poi vabbé saltava qualche volta, ad esempio per il fatto del Covid oppure quando c’è stata la scabbia. Però, se c’era… portavano nel carrello la fornitura, la cosiddetta fornitura cioè:
- Quattro rotoli di cartaigienica per uno;
- Due pacchetti di assorbenti;
- Una saponetta.
E ste cose qua.
Vi dico che prima che uscissi dalla sezione a settembre, gli assorbenti, i vestiti, i prodotti di igiene in generale venivano consegnati solo alle nuove giunte, alle altre no. E se sapevano, a maggior ragione che eri lavorante, ti obiettavano la cosa perché dicevano che non potevi prendere una cosa che toglievi ad altre che non lavorano e che non potevano permettersi di comprarla. Quindi i materiali rimangono là anche per un nuovo arresto, una nuova giunta. La formula era questa e s’è mantenuta diciamo fino a poco fa, poi mo’ non lo so. Da settembre non so se hanno cambiato qualcosa. Perché poi ho notato pure che cambia direzione, cambiano consegne, cambiano regole, cambiano tante cose… ma qui entriamo in un altro discorso.
Richiedere le visite specialistiche in condizioni ristrette
Ho fatto caso che chi fuma, gli si ostruisce diciamo le vene perché l’ossigeno non passa… cioè il sangue non si coagula nella maniera corretta e risente molto di più dei dolori mestruali. Oltretutto, incide anche la quantità di acqua che bevi acqua, il fatto che te mangi gli insaccati, il fatto che te mangi i latticini… Io lo dico sempre a ste ragazzette di non mangia’ sta roba, per un mese e di fare la prova. Perché ti devi conoscere, devi imparare a capire cosa ti fa bene, cosa ti fa male e poi te incanali… E te dai un equilibrio, na cosa.
A. Trovi il giusto rapporto col tuo corpo?
Brava! E allora poi dopo non te stai a lamentà che vai dal dottore “Ah, c’ho quello, c’ho questo, non so che ho fatto…” Anche perché, la ginecologa lì veniva di rado, veniva… a volte vengono. All’inizio venivano chiamate dopo tre mesi, tante se lamentavano. Ultimamente venivano più spesso. Chiamavano spesso il dermatologo che non c’era sempre. Si chiedeva del dentista, di un odontotecnico… sono queste le visite specialistiche più richieste. Poi tra l’altro quando io sono entrata nel 2019 ci fu la campagna per la sensibilizzazione del cancro seno, per le varie cose dei denti… Ci hanno portato alla parte del carcere adibita e ci hanno fatto le visite. Però non passano spesso. Anzi, la detenuta chiede e cerca, però sono gli assistenti, tra virgolette i capi insomma, i sovraintendenti, gli ispettori… che il più delle volte te dicono “Eh devi aspettà, mettite in lista.” Un po’ così…