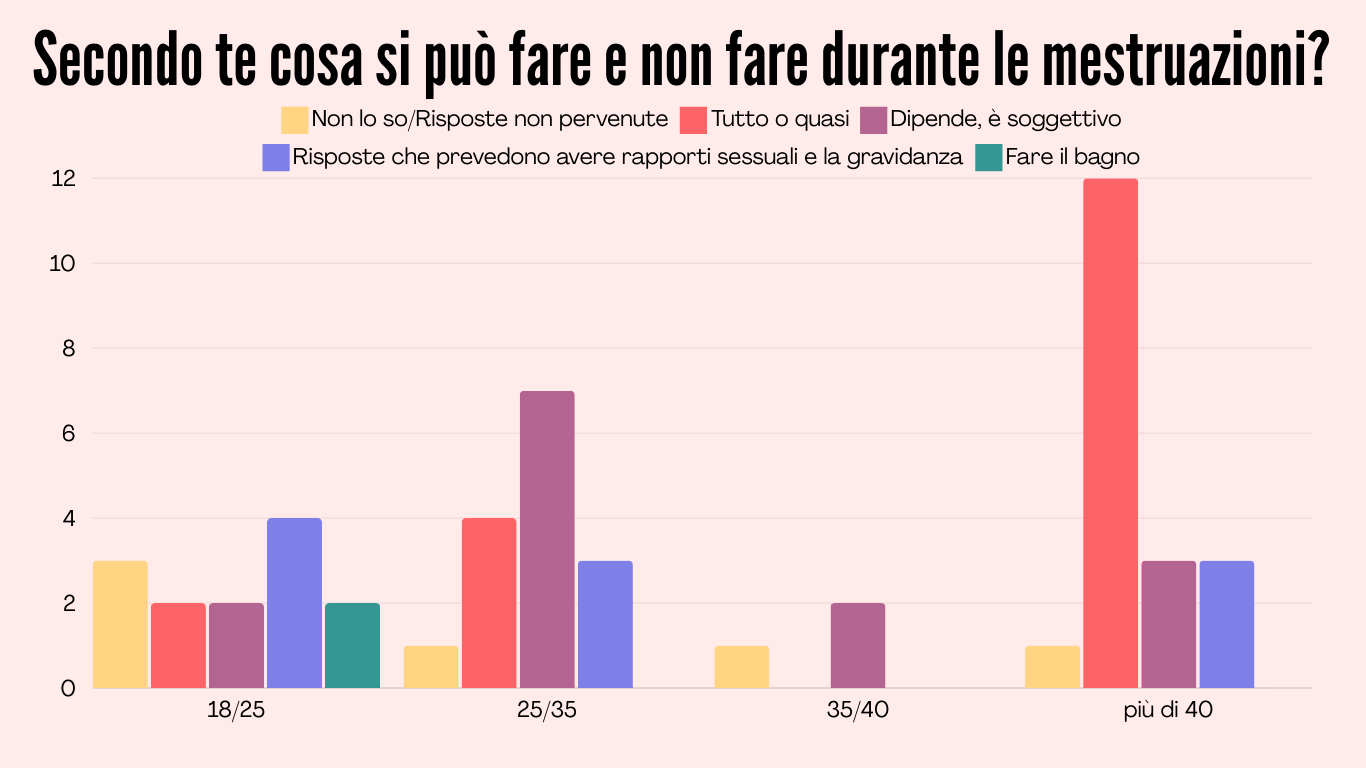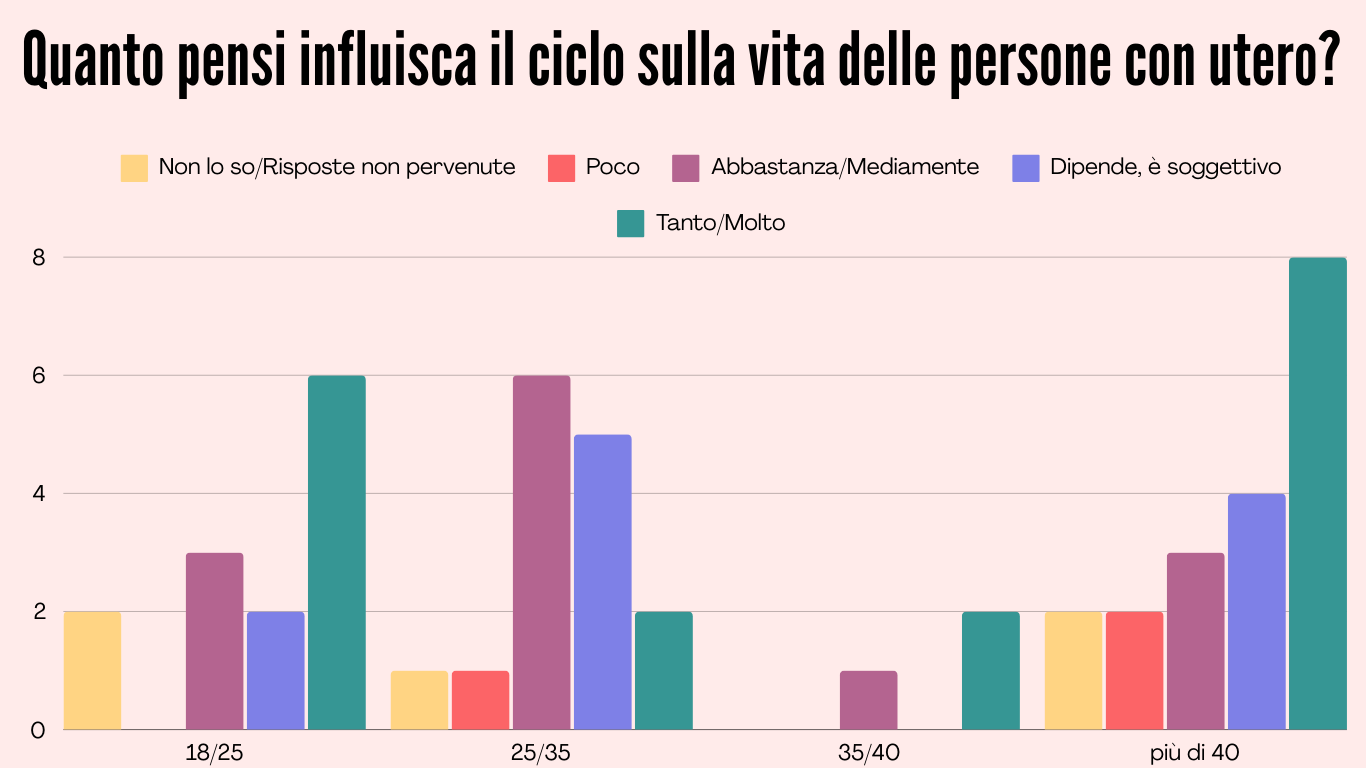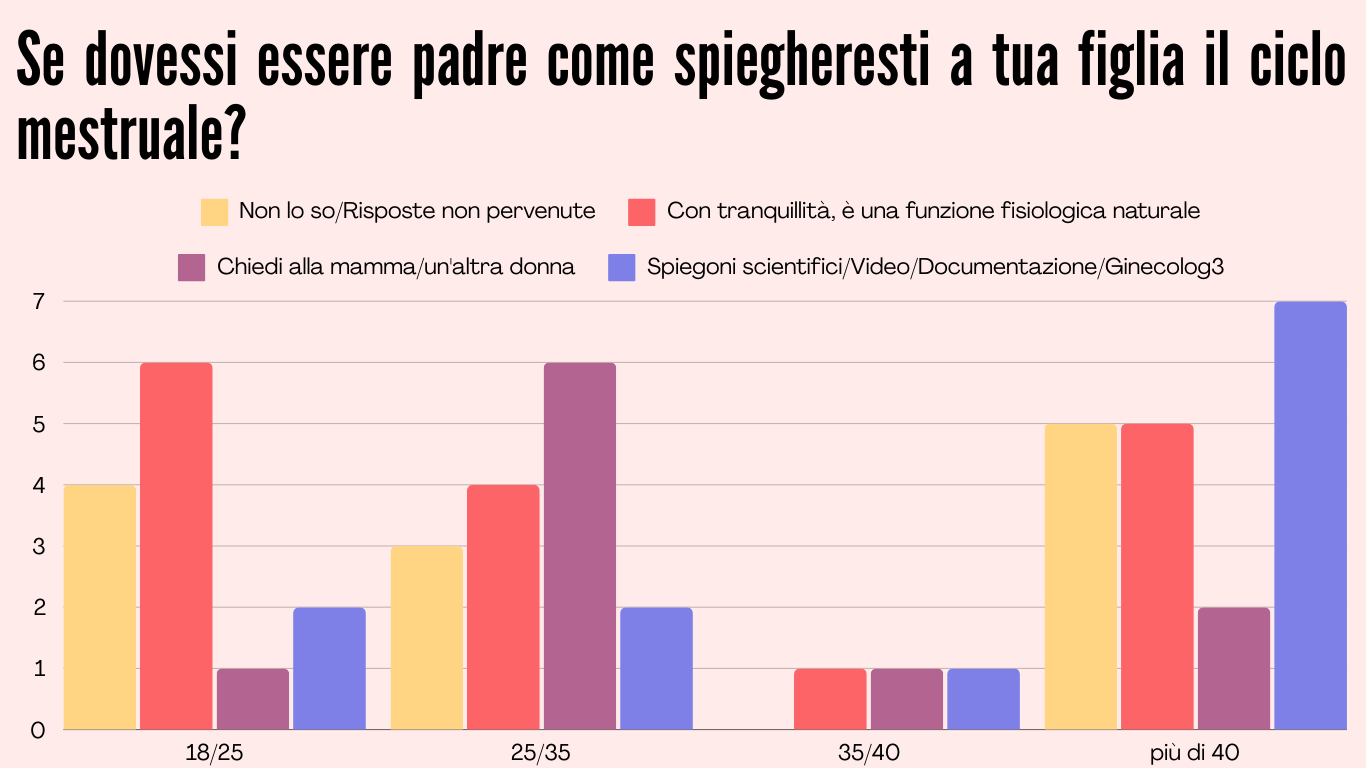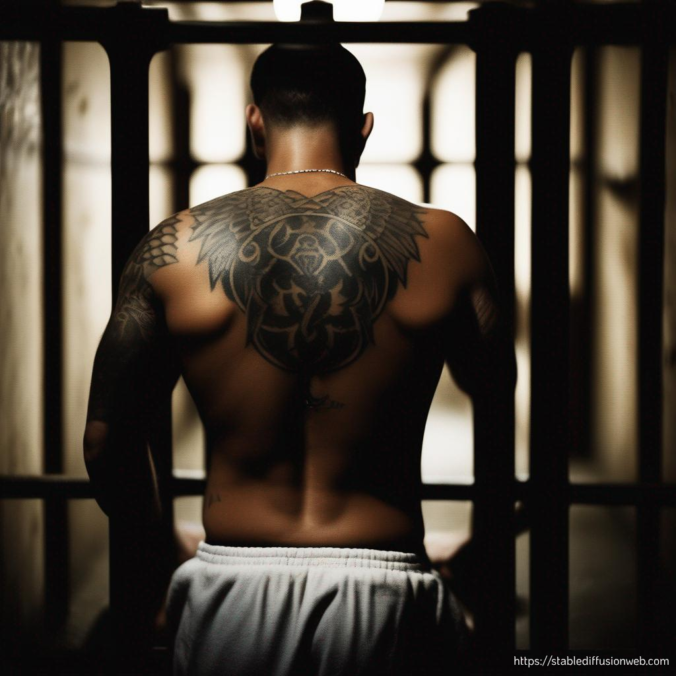ALESSIA
Riflessioni antropologiche sulla categoria del dono nello specifico contesto ristretto del carcere
Scrivo, per i meno avvezzi a quella disciplina semi-sconosciuta che sembra spesso inafferrabile, una parentesi introduttiva sull’antropologia, o perlomeno dello sguardo antropologico che qui intendo assumere.
Molto si è abusato di questa parola evocativa dell’essere umano, nel suo essere-predicato umano-complemento oggetto. Agentività generativa, la cosiddetta agency dell’individuo: quella capacità tutta umana di esserci nel mondo e di crescere, costruire, parlare, adottare sistemi per relazionarsi, concetti, rapporti, regole, contratti, corpi, poteri, parole; e a quel punto dare loro significati.
Alessandro Lupo – docente di antropologia alla Sapienza e Presidente della Società Italiana dell’Antropologia Medica (SIAM) – ha detto che l’antropologia è la disciplina del contesto.
Ogni comunità umana ha una propria specifica cultura e all’interno di essa agiscono, come in un campo di forze, tutte le realtà contestuali che ne fanno parte. Un’antropologa o un antropologo inizia a inseguire, a osservare, ad ascoltare con le mani e a pori aperti le tracce lasciate per tentare un’interpretazione dei significati che hanno intrecciato questa rete, per usare (sicuramente male) le parole di Clifford Geertz.
***Ci giro intorno perché dovete sapere che gli antropologi e le antropologhe, per loro tensione “professionale” a criticare, si criticano di continuo. Interi concetti sono nati così, in dispute generative. Per cui anche dare la propria interpretazione diventa un posizionamento potenzialmente critico.
Quindi forse, la cosa migliore che posso fare è riportare le parole di Jean-Loup Amselle in “Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture”:
«Tradizionalmente, com’è noto, l’antropologia ha identificato il suo oggetto con lo studio delle società primitive o esotiche, anche se, da molto tempo, le si affida anche la descrizione di alcuni settori della nostra società, come l’analisi della stregoneria nelle società contadine, quella delle minoranze etniche, nonché la microanalisi della vita delle istituzioni».
Mi si potrebbe chiedere, se l’antropologia studia i diversi contesti culturali, cosa sto cercando di indagare? Perché assumere uno sguardo antropologico sulle donazioni degli assorbenti alle persone detenute?
Sono principalmente due i soggetti di questa riflessione, il dono da un lato, l’istituzione carcere, dall’altro; entrambe coinvolte nel caso della donazione di assorbenti organizzata dalla Cooperativa PID Onlus ormai da tre anni. Si rifletterà, nei termini della costruzione di una relazione, cosa può significare donare assorbenti alle persone detenute, cosa si percepisce nel ricevere e cosa infine comporta rifiutare di ricevere.
Il dono – la donazione
L’antropologia economica si è a lungo soffermata su questa categoria opaca del dono, leggendo e rileggendo il magistrale saggio maussiano, Essais sur le don (1923-1924).
Marcel Mauss definisce il dono come un fatto sociale totale: pervasivo di tutti gli aspetti costitutivi di una società di individui, da quelli giuridici a quelli religiosi, passando per quelli più strettamente economici e non solo. Determinante le relazioni tra persone, lo scambio di doni può essere descritto attraverso la dialettica del dare-ricevere-ricambiare. Pensiamo a quando, senza uno specifico motivo, una persona che è apparsa da poco nella nostra vita e con la quale non si è ancora in rapporto di amicizia, ci offre un caffè o ci regala una collanina. Come ci sentiamo in rapporto a questo gesto? Oltre alla gioia del ricevere, potremmo provare un po’ di imbarazzo, come se fossimo stati esposti alla terribile condizione di debito nei confronti del donatore. Stiamo sperimentando in quel momento la terza fase della dialettica del dono: quella dell’obbligo di ricambiare.
Nel momento in cui, incontreremo nuovamente la persona che ci ha offerto un caffè in precedenza, faremo in modo di ricambiare con un altro caffè, sentendoci quasi sollevati da un peso; il peso dello squilibrio tra le parti all’interno di un potenziale legame sociale.
Ora, per non far aggrottare la fronte dei miei amici che contestano ogni volta questo discorso affermando con fierezza il loro completo disinteresse nel fare regali, è chiaro che esistono diversi tipi di doni, potremmo dire che ne esistono tante quante sono le relazioni sociali. Qui non abbiamo lo spazio necessario per approfondirli tutti, per cui ci occuperemo solo di definire la ragione – individuata da Mauss – che spinge il ricevente a ricambiare il dono ricevuto.
Mauss, osserva questo movimento del dare-ricevere-ricambiare messo in atto nella cerimonia-rituale del potlàc. Principalmente adottato tra le popolazioni Kwakiutl, Haida e Tinglit, il potlàc è un rituale la cui essenza è proprio l’obbligo di dare. Durante i mesi invernali, un capo deve dare dei potlàc: invitare altre tribù o clan alla festa in cui si pratica questo gioco dei doni e donando tutto quello che è riuscito ad accumulare, oltre a redistribuire le ricchezze, assicura la garanzia del proprio prestigio, del proprio rango, della propria persona. Dall’altra parte, chi riceve l’invito alla festa kwakiutl è a sua volta obbligato ad accettare, perché altrimenti si ammetterebbe una sconfitta in partenza: si ammetterebbe cioè la paura di dover ricambiare. All’estremo opposto del darsi per vinti, il rifiuto del potlàc di un altro può significare dichiararsi invincibili. E questo, comporta in genere un conflitto tra le parti. Di regola però, i doni si accettano:
«Bisogna apprezzare ad alta voce il cibo preparato per voi. Ma, accettandolo, si sa bene di rimanere impegnati.» – Il saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche.
L’impegno che si assume è quello di ricambiare, in eguale o maggiore misura di quanto si è ricevuto, pena non solo la “perdita della faccia” ma anche lo status di schiavo per debito.
In questo quadro, la donazione di assorbenti alle persone detenute all’interno di un penitenziario italiano, è in qualche modo ascrivibile a un dono che – passando da fuori a dentro – connette una parte della società “libera” (la Cooperativa, le persone e le associazioni del terzo settore che hanno aderito all’iniziativa) con una parte della società reclusa (le persone con utero beneficiare degli assorbenti). Ma non è proprio così, perché alle persone ristrette in carcere non è dato il diritto di accettare il dono e in alcuni casi, neanche di riceverlo. A rispondere per loro, saranno i “capi”: quelle soggettività che assumono i ruoli di detentori di un certo potere all’interno di un’istituzione. Sono l’interfaccia con cui ci si relaziona prima di oltrepassare fisicamente i cancelli del carcere (in veste di volontari, operatori ecc.) e come in questo caso, prima di far passare scatole di oggetti di necessità primaria.
Probabilmente è ancora poco chiaro cosa ci sia alla base del sentire l’obbligo di ricambiare, Mauss ha parlato dello spirito delle cose, riferendosi più nello specifico a quegli oggetti “sacri”, quelli che potremmo definire inalienabili, i quali contengono, ricordano e trasmettono l’anima del proprietario. Come l’anello della nonna che passa di madre in figlia, tutti quegli oggetti intrisi degli spiriti dei donatori fanno sì che il loro valore sia superiore a qualsiasi quantitativo in denaro.
«Ti dirò di più che quando venivano co’ i carrelli perché *** aveva mandato che ne so, du’ pacchetti de caffè co’ i biscotti (i biscotti quelli non ce stanno, tipo batticuore, pandistelle…) c’era una felicità immensa che sembra che chissà che cosa hanno avuto. C’è una gioia veramente nel cuore. Te portano tante cose, anche i reggiseni, magari so ‘ncolore differente ma il modello è quello. Le pantofole che io ancora ho de *** è ‘na gioia immensa… “A te de che colore te l’hanno dato?”… Chi se li scambia… Addirittura tanti fanno i pacchi, li mandano in uscita per i propri parenti, per i nipoti, per i figli. Hanno portato, mi ricordo, le magliette della Lazio, della Roma… le tute quelle svasate fatte a campana. […] Tutte contente, tutte entusiaste, quindi sposano bene l’idea. Non se sentono abbandonate, dice “ah menomale c’è qualcuno che ce pensa.” E quindi son contenti di questo.» – Intervista a Rosaria, qui per leggerne di più.
Dalle parole di Rosaria, una signora che ho avuto modo di conoscere per una breve chiacchierata sull’esperienza delle mestruazioni in carcere lo scorso mese, emerge qualcosa di quel “potere” – passatemi il termine – interno alla cosa donata. Che sia un pigiama, una ciabatta o un pacco di assorbenti, ciò che arriva prepotente dentro è una porzione del fuori, è qualcosa che dice alle persone detenute che non sono state dimenticate né abbandonate.
Un legame, non tanto con persone singole, piuttosto con una collettività rappresentativa della società “civile”. Di quel rapporto è privata la popolazione detenuta alla quale è negato il diritto di ricevere una donazione di assorbenti. Una relazione che con una semplice donazione potrebbe muovere i primi passi per qualcosa di più grande, di più coinvolgente e duraturo. Per fare solo un esempio, pensiamo ai laboratori organizzati dalla Cooperativa PID Onlus, promossi dal progetto Assorbire il cambiamento, inserito nel più ampio POSTER, coordinato da Aidos.
L’esigenza degli assorbenti per il carcere
«Innanzitutto funziona che quando entri in carcere ti viene data una tra virgolette “dotazione” perché ti assegnano una cella, un letto se la cella è per più persone… La dotazione sono le lenzuola, una specie di asciugamano, un asciughino per i piatti, bicchieri e posate di plastica e una saponetta e poi non è detto che te li diano all’inizio ma comunque puoi chiedere un pacco di assorbenti al mese. Ok? […] Ovviamente sono indecenti come assorbenti, come qualità e soprattutto sono pochi. […] Sono cose di quelle tipo materassino, magari stretti e lunghi comunque non si trovano in commercio… Sono quelle sottomarche che magari possono andare a finire non so dove ma sicuramente c’hanno dei fornitori che producono proprio per il carcere insomma. Anche se sono diversi… i pacchetti non sono sempre uguali, no? E quelli si riforniscono… E quello te ne spetta solo uno. […] Un pacchetto standard che ti deve durare. Chiaramente il problema sta nel fatto che quasi tutto quello che ti danno loro non ti può bastare. No? Una saponetta non ti può bastare un mese. Una spugnetta, pe ditte, una spugnetta dei piatti magari un mese non basta perché quelle spugnettine tipo per pulire si sbriciolano no?Poi se vanno a contatto con la varechina è finita, so’ morte subito, istantaneamente. Quindi lì il problema… In carcere è sempre un problema di status economico, se c’hai chi ti può dare i soldi da fuori puoi comprarti, che ne so, il bagnoschiuma, lo shampoo…» – Intervista a Maria, qui per leggerne di più.
Nel 2022 e nel 2023, la Cooperativa PID Onlus ha organizzato una campagna di raccolta assorbenti per le persone detenute all’interno degli istituti di pena femminili. L’istituzione carcere può essere vista un po’ come lo specchio della società “legittima” quando si parla di gender gap e non solo. Non è un segreto, molti ne hanno parlato in questi tempi: il penitenziario è un sistema “pensato al maschile” ma che ha tentato, attraverso vari regolamenti nel tempo, di smussare gli angoli in favore delle identità femminili presenti al proprio interno.
«Il bidet, previsto esplicitamente dal regolamento del 2000 i reparti femminili, è garantito solo nel 66% degli istituti dove sono ospitate donne» – Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, L’Osservatorio di Antigone nelle sezioni femminili d’Italia (2023)
Tra gli standard internazionali delle Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reato (Regole di Bangkok, luglio 2010) sono presenti indicazioni anche riguardo l’igiene e la distribuzione gratuita degli assorbenti che non sono tradotte nella legislazione italiana.
Così, andando incontro a questa esigenza, la Cooperativa PID da marzo a maggio 2024 ha proposto un’iniziativa che prevede, oltre alla raccolta in sé delle azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema del ciclo mestruale in carcere.
«Tra le attività promosse, oltre alla donazione di assorbenti, sono previsti laboratori e incontri all’interno di Istituti femminili per promuovere maggiore consapevolezza sulle tematiche riguardanti il ciclo mestruale e la conoscenza dei “nuovi” prodotti igienico sanitari più ecologici quali coppetta, slip e mutande assorbenti. Il progetto ha lo scopo di portare un beneficio concreto alle persone recluse grazie alla donazione di materiali sanitari, di accendere l’attenzione della società, delle istituzioni e della cittadinanza sulla condizione delle donne recluse, nonché di raggiungere un cambiamento sistemico della questione affrontata.» – Dal comunicato stampa 8 marzo 2024
Alla fine della raccolta, prevista per il 23 maggio, le operatrici e gli operatori del PID Onlus hanno contato più di 2000 assorbenti da destinare agli istituti penitenziari laziali e alle strutture di accoglienza per persone detenute ed ex detenute che hanno aderito:
- Istituto penitenziario di Civitavecchia;
- Struttura di accoglienza per persone detenute ed ex detenute Casa Teseo;
- Casa di Leda;
- Casa famiglia dell’Associazione di volontariato Ain Karim.
Confrontandoci tra di noi, non possiamo che dirci soddisfatti del lavoro di condivisione svolto fino a oggi. Siamo felici soprattutto di aver allargato il discorso sulle mestruazioni ristrette anche a chi, pur mantenendo la propria opinione sui carcerati, non ha nascosto il proprio stupore nei confronti di una mancanza così importante per la vita quotidiana delle donne.
Le perplessità interne sono state relative alla non completa disponibilità a ricevere la donazione, soprattutto in seguito alle testimonianze delle persone che, da poco uscite, raccontano della sentita necessità di beni primari che non sono accessibili per tutte e tutti.
La risposta disillusa di Sonia “è tutto business” alla nostra domanda “secondo te perché non tutti accettano le donazioni?”, ci fa ragionare. Abbiamo tentato di inquadrare la questione nella più complessa matassa di relazioni e non-relazioni che può caratterizzare il carcere, un’istituzione chiusa in se stessa.
***Prometto che sono quasi alla fine!
L’Istituzione carcere
Ancora nel 2024, sembra quasi impossibile parlare di istituzioni e non citare Michel Foucault, non sarò io a rompere questo cerchio. Ne “La volontà di sapere. Storia della sessualità 1” si affronta, oltre al focus principale dell’intrinseca relazione tra potere-sapere sul sesso e la sessualità, anche una ricostruzione della critica delle istituzioni politiche che nel XIX secolo diventa più radicale.
«[…] poiché si trattava di mostrare non solo che il potere reale sfuggiva alle regole del diritto, ma che lo stesso sistema del diritto non era che un modo di esercitare la violenza, di annetterla a profitto di alcuni, e di far funzionare, sotto l’apparenza della legge generale, le dissimmetrie e le ingiustizie di una dominazione.» – La volontà di sapere. Storia della sessualità 1.
Se si pensa bene al carcere, ci si rende conto di una contraddizione che soggiace allo stesso statuto delle pene posto dalla Carta costituzionale italiana. Una contraddizione che sta, più precisamente tra il testo e la sua applicazione. In un incontro organizzato dall’associazione Parliamo di carcere lo scorso 11 maggio, il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia ha sottolineato come chi ha pensato e scritto la Costituzione ha dato direttive sulle pene senza nominare direttamente l’istituzione carcere.
Chi lavora, studia o abita questo ambiente forse lo conosce a memoria, ma riprendiamo l’Art. 27 della Costituzione riguardo alle pene, il quale recita così:
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.»
Parliamo di rieducazione e di risocializzazione come scopi ultimi delle pene, da un lato e di un’istituzione totale che separa – come prima e solenne ragion d’essere – le persone che commettono il reato dal resto della società nella quale è previsto il cosiddetto reinserimento.
Il carattere solenne della separazione può essere esemplificato dall’impatto che provoca a un corpo libero il confronto con un alto muro di cemento grigio.
Nonostante i tentativi che si sono susseguiti nella storia per limitare gli aspetti più violenti e disfunzionali del carcere, la realtà è ben diversa e si caratterizza, ricorda Luca Sterchele per una:
«permanenza e pervicacia di quelle sue “funzioni latenti” aventi a che fare con la produzione di sofferenza, la disabilizzazione delle soggettività, la riproduzione delle “classi pericolose” e del nemico interno, da sempre innervate nel suo funzionamento.» – Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario.
Dentro gli spazi ristretti e costretti di una cella, vivere quel sanguinare comune che accompagna una buona parte dell’esistenza delle persone con utero diventa un disagio nel momento in cui non si hanno le possibilità di acquistare i prodotti igienico-sanitario che si necessitano o che si preferiscono. Non solo si nega il controllo sul proprio corpo in relazione a una delle esperienze più soggettive che esso attraversa ciclicamente ogni 28 giorni, si annulla la facoltà di scegliere tra i dispositivi mestruali quelli che rispondono meglio alle singole necessità personali. Sulle esperienze del corpo delle donne nei penitenziari, proprio in relazione al vivere il ciclo sono ancora Rosaria e Maria che raccontano di quelle persone a cui, per lo “shock del carcere” il ciclo si blocca, non viene più per mesi. Potremmo parlare in questo caso, con Francesca Cerbini, di “prigionizzazione”: un termine utilizzato in criminologia per definire il processo di assuefazione al carcere, alle sue regole e alla nuova vita che si prospetta per una persona che entra.
«[…] la prigionizzazione si concepisce fondamentalmente come un effetto della carcerazione sulla psiche, la cui alterazione sfocerebbe in “sindromi di reazione alla reclusione”, visto che la permanenza in istituzioni chiuse produce una lunga serie di effetti psicopatologici. […] Ma nemmeno il “fisico” riesce a nascondere le conseguenze perniciose della vita trascorsa in cattività e della prigionizzazione.» – La casa di sapone. Etnografia del carcere boliviano di San Pedro.
Chiudendo questa parentesi sui corpi reclusi nei penitenziari, torniamo alla domanda che sta alla base di questo articolo un po’ più lungo dei soliti: cosa ci dice un’istituzione che non accetta una donazione di assorbenti? Forse ci dice che non vuole rapporti col fuori. Forse ci dice che non c’è possibilità di apertura o di connessione.
Il non detto del carcere è rintracciabile nel suo rifiuto di un dono – che abbiamo visto essere potenziale mezzo di creazione di legami sociali – e allo stesso tempo nel suo rifiuto senza dare spiegazioni. In parte l’abbiamo già affrontato, il sottotesto che muove l’istituzione penitenziaria, quando abbiamo parlato della contraddizione tra disposizioni risocializzanti e realtà desocializzanti; ma perché l’arrivo degli assorbenti destabilizzerebbe l’ordine interno? Probabilmente, quella gioia del cuore di cui ha detto Rosaria, cozza con la “funzione latente” di produzione della sofferenza specifica del carcere.
Questa è l’unica risposta che – riflettendo in questi mesi – ha continuato a ritornare nella mia mente, mentre ne cercavo altre che avrebbero potuto avere forse un risvolto più roseo. Perché è importante parlare di questo e riflettere su un rifiuto distratto a una donazione di qualcosa di così necessario?
Perché se non lo facciamo «stiamo già parlando la lingua dell’istituzione, lasciamo filtrare il discorso del carcere e, come Eichmann in sedicesimo, diciamo che “stiamo solo obbedendo agli ordini”.» – Piero Vereni. “Catene d’amore, ovvero la statalità del male.”