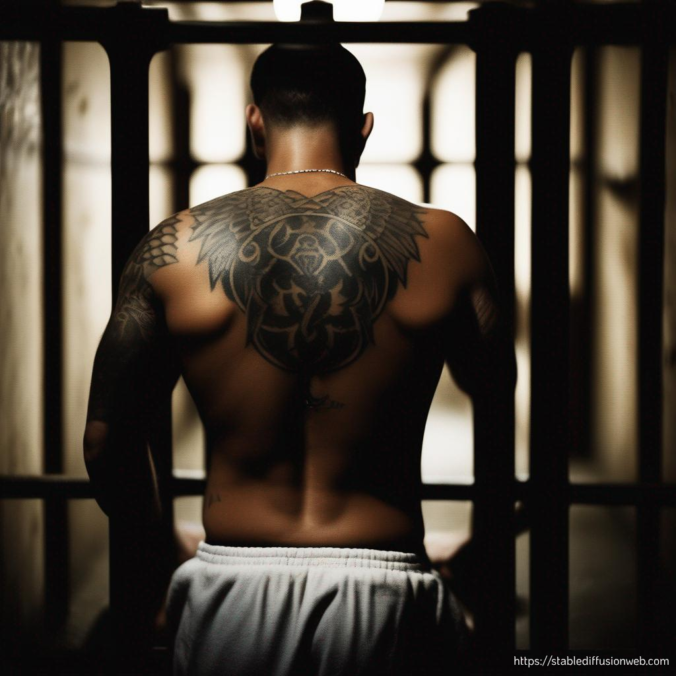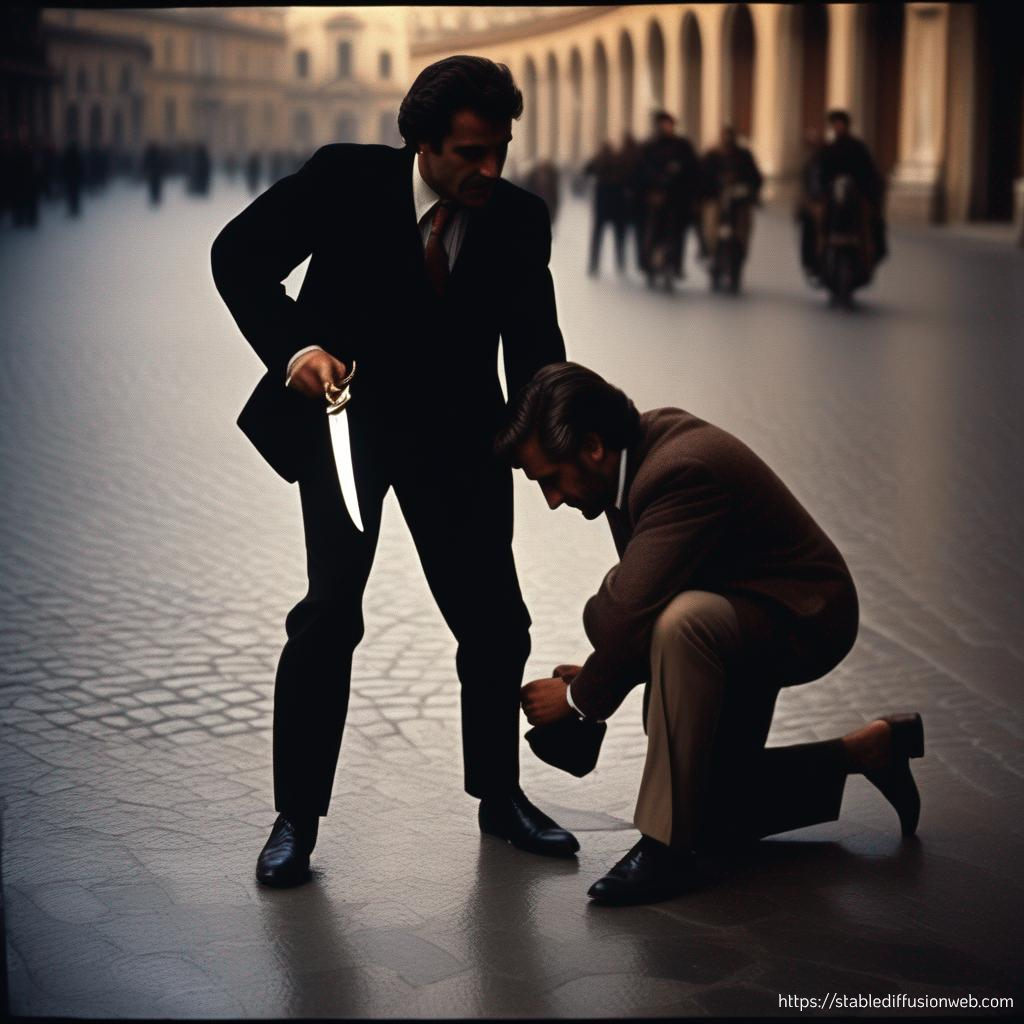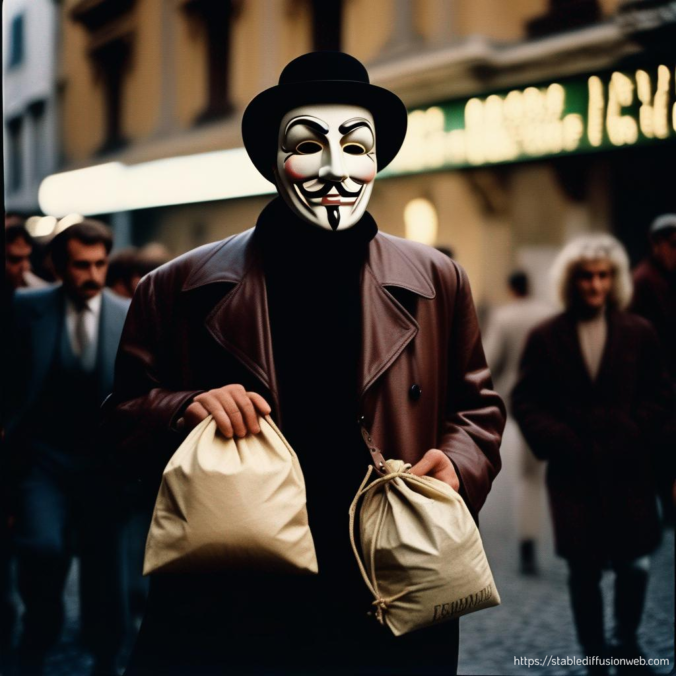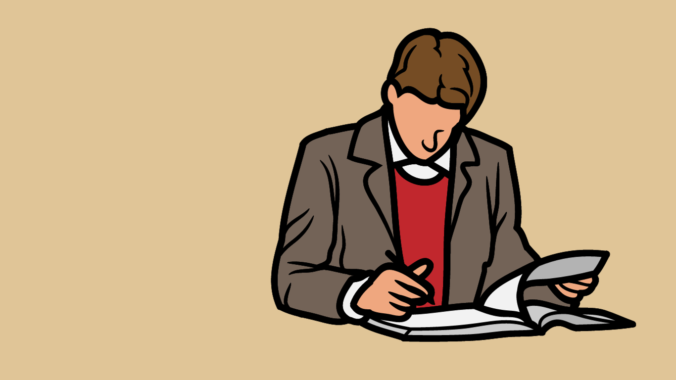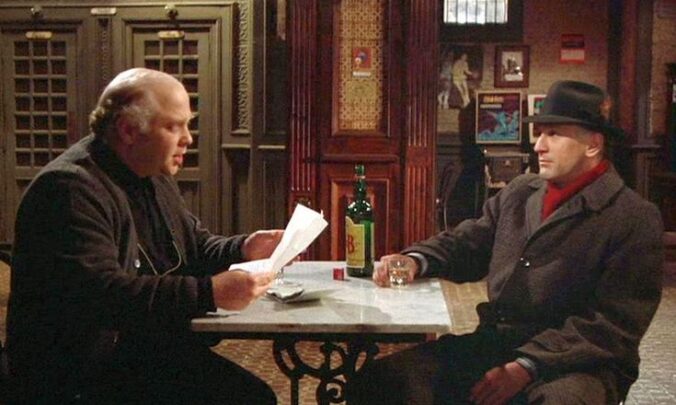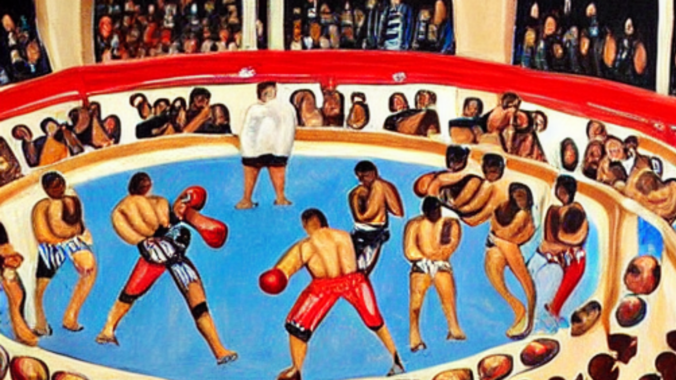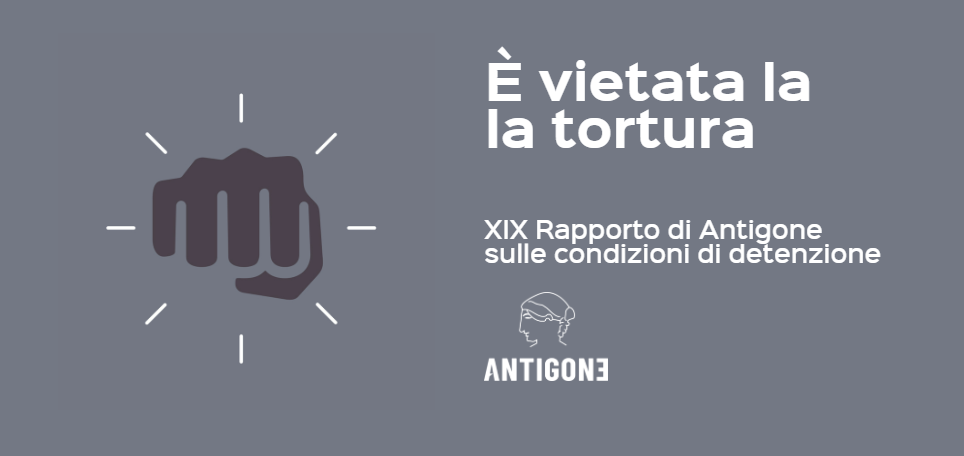ALESSIA

Siamo in ritardo, sì. È passato più di un mese dall’ultimo incontro del Club del libro della Casa famiglia Don Pino Puglisi. Eppure del secondo libro che abbiamo letto e di cui si è discusso ci siamo quasi dimenticati di scrivere le riflessioni emerse. Tra gli impegni quotidiani e la scelta dell’autore o autrice di questo articolo, alla fine eccoci qui.
Vi racconto io com’è andata la mattina dello scorso 23 maggio in casa famiglia. Ci siamo riuniti tra ospiti, operatori e operatrici, una persona volontaria e tanto cibo (quello non manca mai!). In questo incontro si sono aggiunte due persone nuove rispetto al primo, il club cresce anche se non tutti avevano letto il fumetto di ZeroCalcare che avevamo scelto. Ne abbiamo parlato quindi in grandi linee, tracciando la trama per chi se l’era perso.
Chi racconta la trama e specifica nei particolari più propriamente letterari dei testi scelti è sempre Bruno – nome di fantasia – che ha informato gli altri membri sul contenuto e la forma de “La profezia dell’armadillo”.

La profezia dell’armadillo
Il primo fumetto di ZeroCalcare, edito nel 2011, ci dice già molto del suo personaggio autobiografico. Zero si vede alle prese con un evento difficile che attraversa la sua vita, la travolge, forse la cambia: la morte di una sua vecchia amica, una ragazza per cui ha avuto a lungo una cotta taciuta. Un lutto da portarsi dentro con tutti i dilemmi e le domande che lascia, come un buco nero che risucchia il tempo, la storia di chi resta.
Nella cornice principale del testo si vede Zero e il suo fedele amico immaginario Armadillo – rappresentativo della coscienza e della parte più intima e paranoica del sé – cercano di districarsi nelle maglie dell’evento luttuoso: dalla notizia della morte di Camille, una giovane ragazza come lui e il suo amico Secco , che soffriva di disturbi alimentari, al suo funerale.
Il fumetto è attraversato, quasi ad intervallare i momenti di angoscia che scandiscono i pensieri del protagonista, da continui flashback cronologicamente disordinati che compongono una serie di mini storie ambientate nel quartiere romano di Rebibbia.
Ci siamo soffermati sulle diverse tematiche affrontate dall’autore e i protagonisti delle vicende, Giorgio poi – un altro nome di fantasia – come spesso fa, pur non avendo letto il fumetto si è fatto trovare preparato: prima dell’incontro aveva sbirciato su internet qualche commento interessante da proporre, come se fosse tornato di fronte una cattedra di scuola!
Le tematiche su cui abbiamo ragionato principalmente sono state tre:
- Il ruolo dell’armadillo e la sua profezia;
- L’attesa del momento perfetto;
- Sull’immagine del “Porta-spade di Damocle”.
Il ruolo dell’armadillo, la coscienza, la parte inconscia, la voce che parla delle paure, delle ansie, dei rimorsi del passato, delle scelte non prese e di quelle invece prese in modo sbagliato. Abbiamo riflettuto sui mostri che ognuno di noi si porta dentro, con Virginia si è parlato della differenza tra l’Armadillo di Zero e l’ombra scura, alta, gigante di Camille. In una scena del fumetto infatti, quando i due amici Zero e Camille si ritrovano dopo tempo a passare la notte a casa del primo e decidono di lasciare i pensieri fuori dalla porta della camera. Le due immagini messe vicine, in silenzio, palesano il contrasto tra un essere buffo color arancione e uno spaventosamente buio. Ci siamo chiesti quanti e quali pesi ci si porta dentro senza condividerli con chi ci sta intorno, come questi crescano auto-alimentandosi delle nostre paure, come invece anche solo accogliere l’ascolto dell’altro possa aiutarci a schiarirli, a renderli più piccoli, o più leggeri.
«Si chiama profezia dell’armadillo qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti, nei secoli dei secoli. Amen.»
Giorgio ha letto in una prospettiva pessimistica la profezia autoavverante, ragionando su come a volte succede che siamo talmente in ansia per qualcosa di importante che aspettandoci il peggio, lo facciamo arrivare sul serio. Livia ha sottolineato invece l’ottimismo positivo che ci dà fiducia e che ci rende per questo più propensi a ottenere quel che ci prefiggiamo, dai piccoli successi quotidiani agli obiettivi di vita più grandi.
L’attesa del momento perfetto, condensata nell’immagine del tempo che fa ticchettare l’orologio nella testa di Zero ogni volta che prova fin da adolescente a esprimere i suoi sentimenti romantici per Camille: il tempismo che ripete “non è il momento” fino a quando quel momento non potrà più arrivare, con la morte della ragazza, l’orologio si arresta. Queste scene in particolare hanno riportato alla memoria degli ospiti più in là con gli anni i ricordi di relazioni di ambiguità con amicizie perdute da tempo. Abbiamo aperto una parentesi sugli approcci romantici di ognuno, sul rispetto, sul consenso.
«La porta-spade di Damocle. Ideale per chi: è in attesa di rinnovo del contratto, è in attesa di pagamento di arretrati, è in attesa di sfratto esecutivo, è in attesa di giudizio, è affettivamente precario, è in attesa dell’esito di un colloquio, è in attesa di un esame.»
Anche questo sentimento di attesa che immobilizza la quotidianità e ci sospende dalla realtà è ritratto in modo lucido e ironico da un Zero legato a un marchingegno dal quale pendono sulla sua testa una serie di spade pronte a trafiggerlo o a cadere terra lasciandolo illeso. Abbiamo riflettuto sul senso di insoddisfazione che in questi momenti ci rende incapaci di essere fieri del nostro operato perché troppo concentrati ad aspettarne i frutti.

Tra una battuta e un’altra l’incontro si è concluso serenamente, abbiamo messo molta “carne sul fuoco” e abbiamo deciso poi di optare per il terzo libro su qualcosa del genere giallo o thriller in linea con i gusti del nuovo membro del club. In vista dell’estate, siamo un po’ più pigri e probabilmente risentirete del club del libro della casa famiglia direttamente a settembre. Ci salutiamo qui quindi, consigliando a chi non l’ha già fatto la lettura rigenerante di ZeroCalcare, in grado di sprofondare nelle tematiche più difficili con una leggerezza disarmante che fa sorridere chiunque.