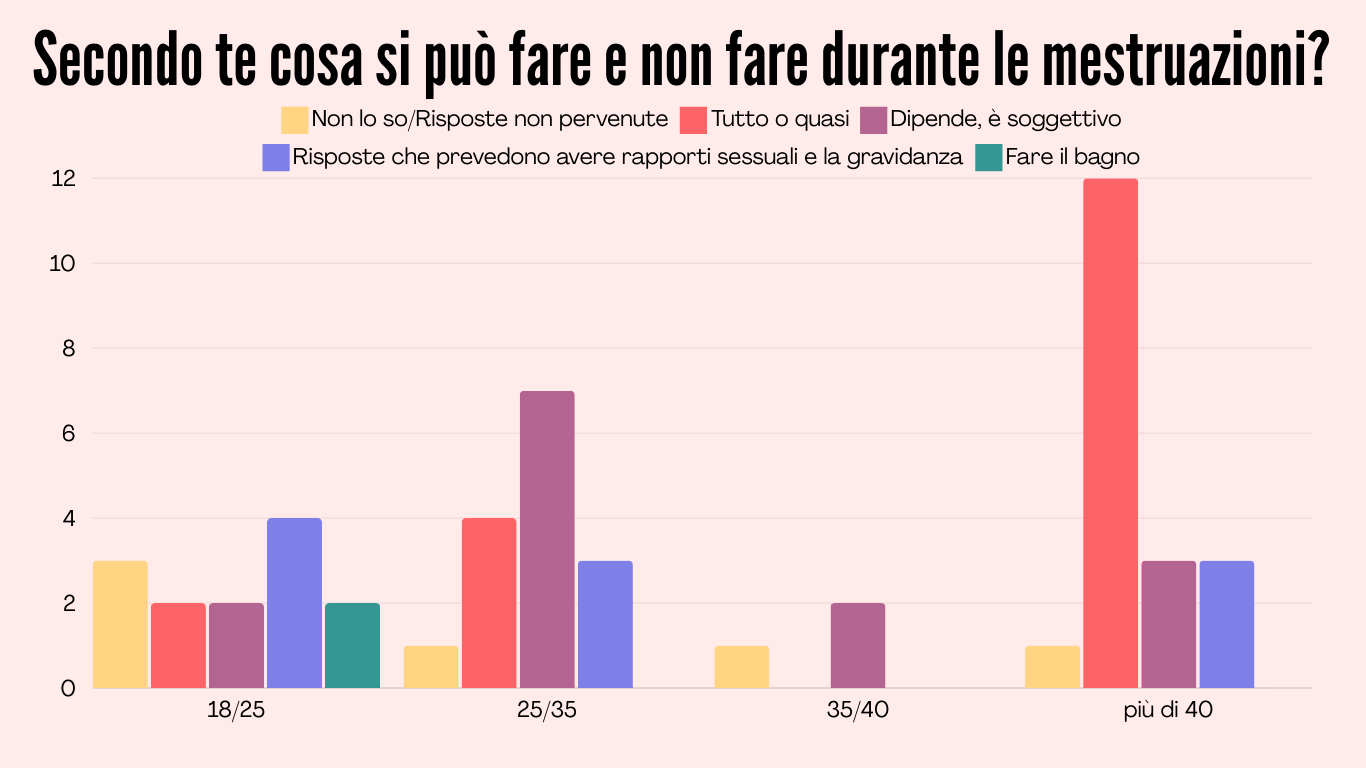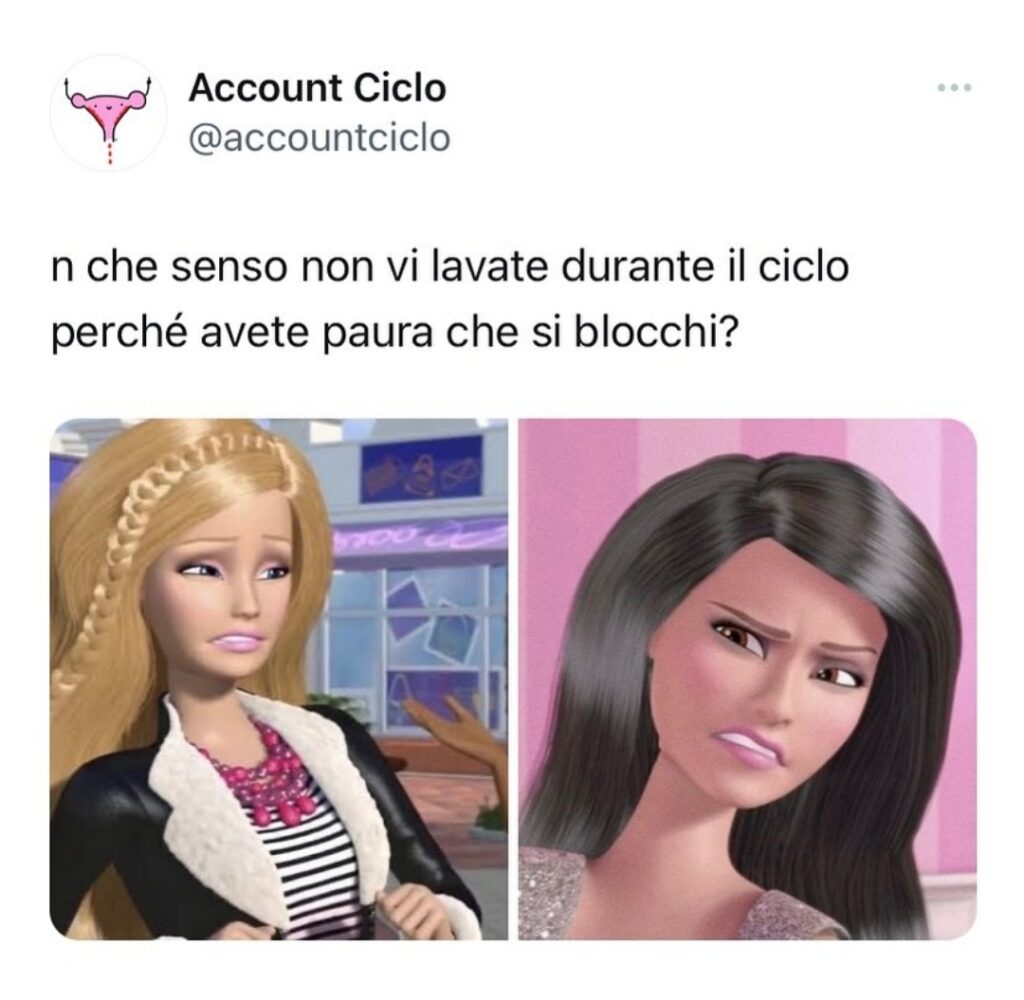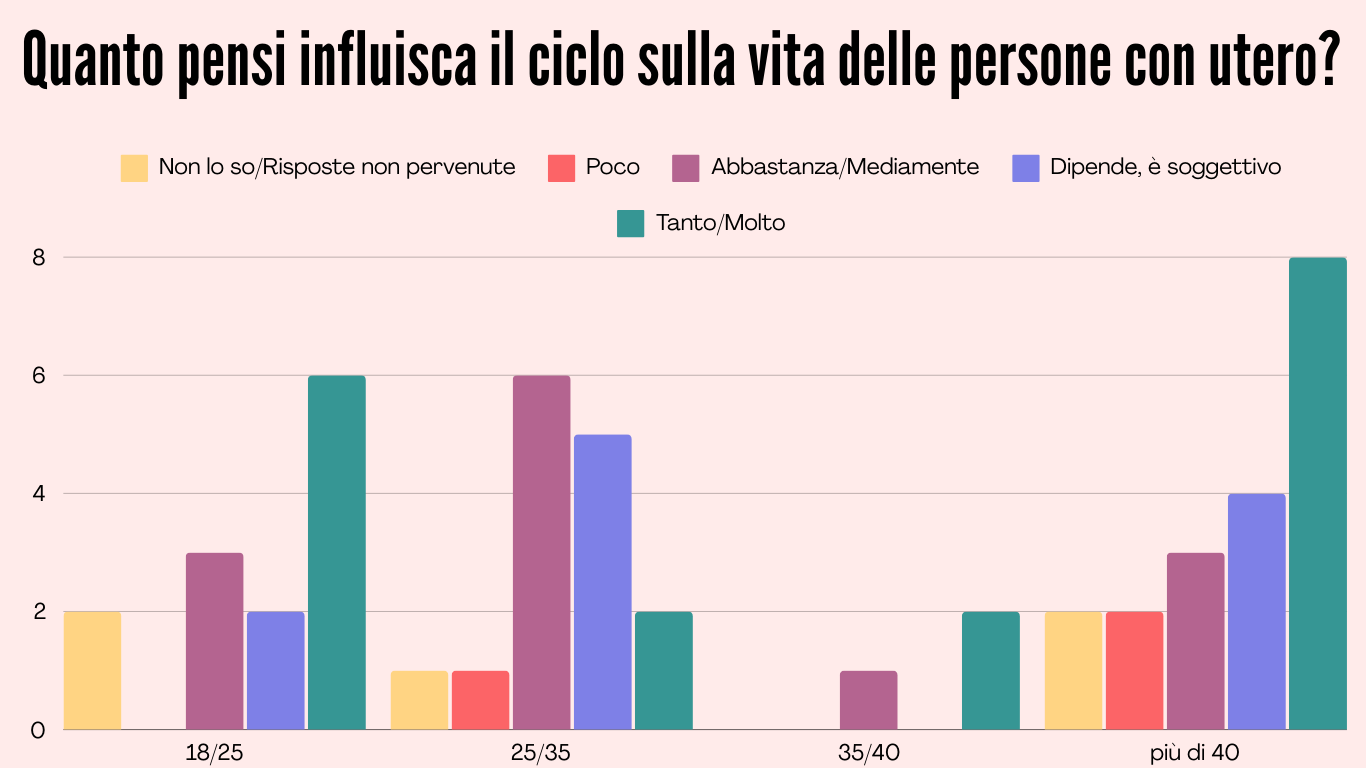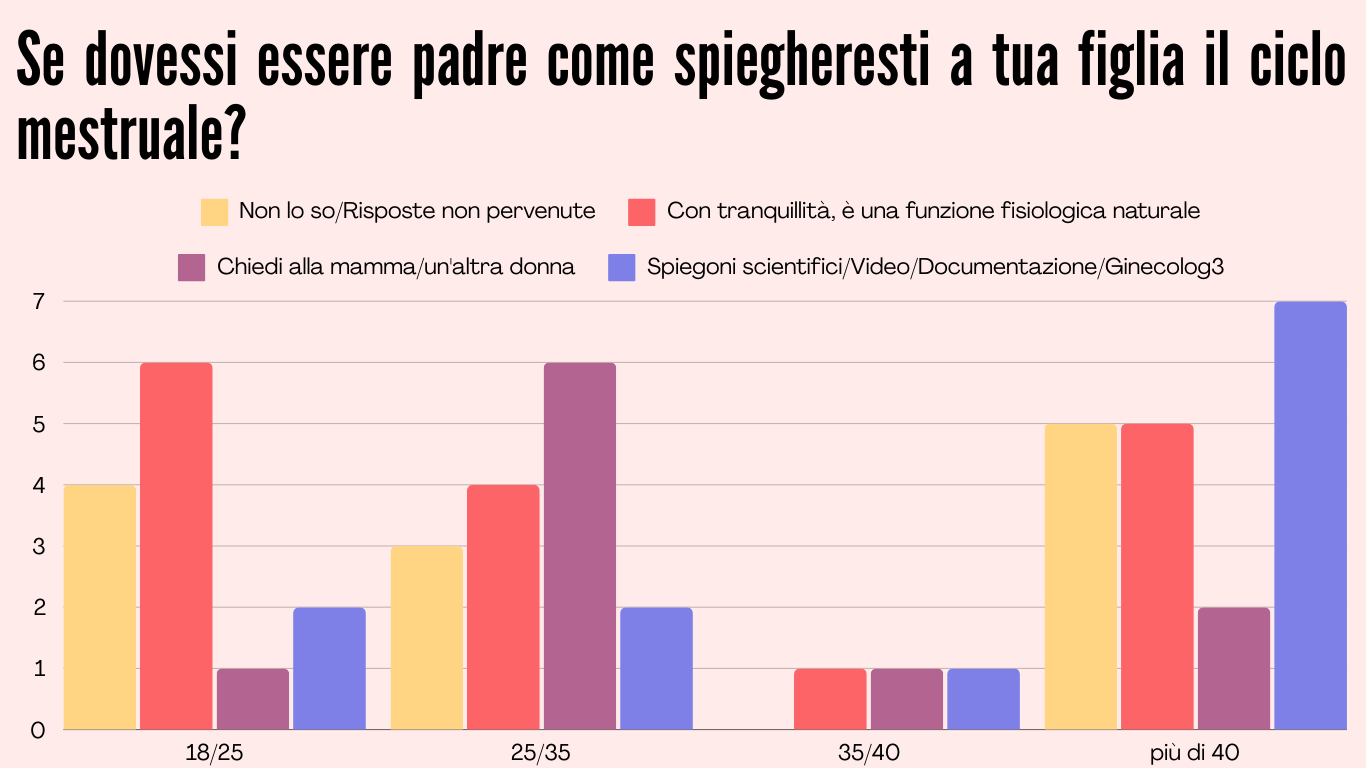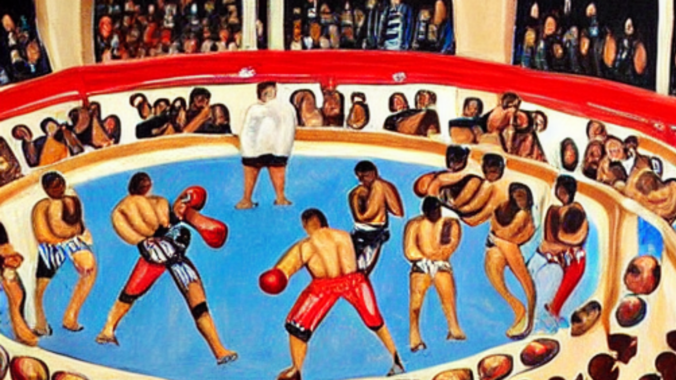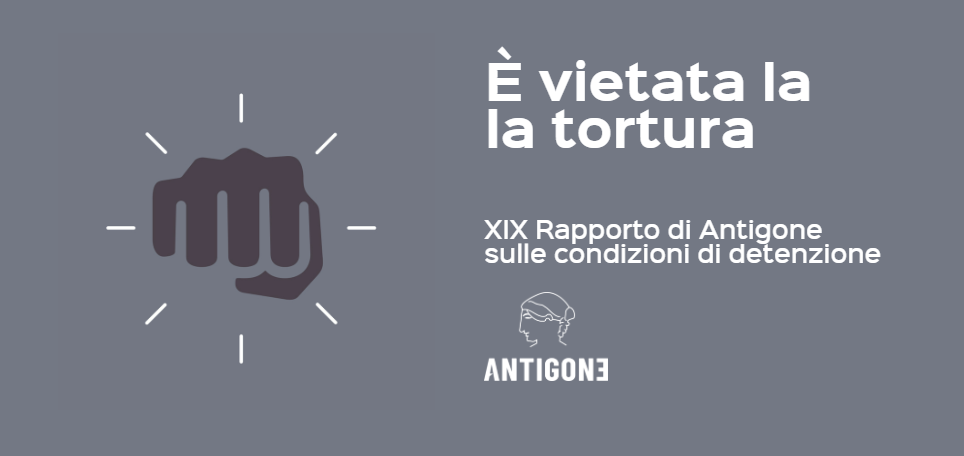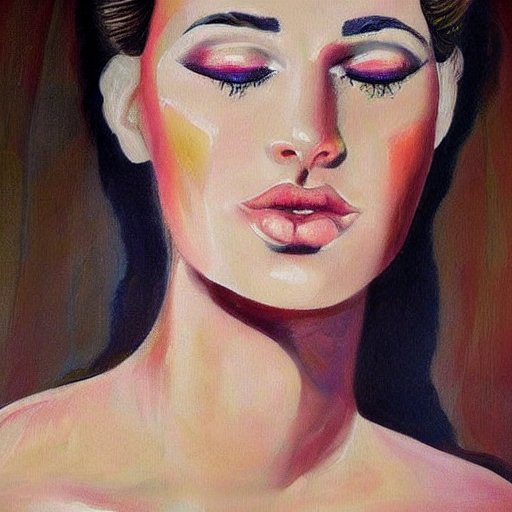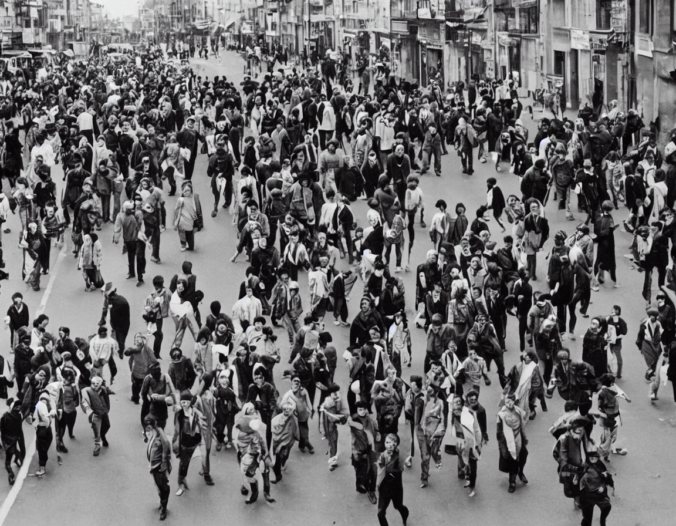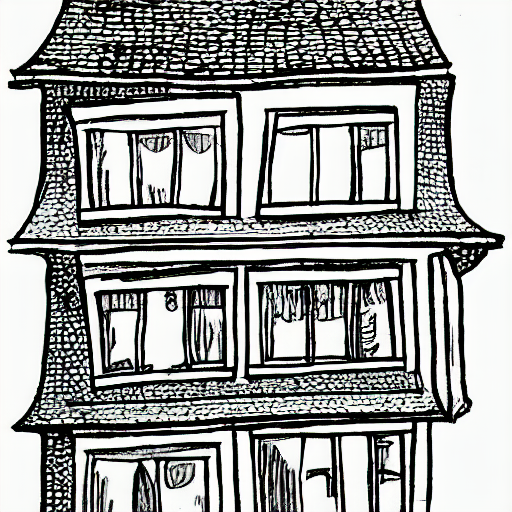ALESSIA
Assorbire il cambiamento è il progetto che abbiamo promosso quest’anno, ormai lo sapete bene. Dall’otto marzo al ventotto maggio abbiamo raccolto gli assorbenti per le persone detenute in carcere e nelle strutture di accoglienza. In questi mesi abbiamo incontrato le esperienze di alcuni vissuti di dentro, ne abbiamo parlato, siamo stat3 dentro le storie di chi ha dovuto gestire in una quotidianità ristretta le mestruazioni.
Ripercorrendo nella mia mente le loro voci, i loro sguardi, i loro sorrisi sarcastici, mi rendo conto della continuità di tutti i racconti: gli assorbenti in carcere servono, quando arrivano non sono sufficienti, non sono per tutt3, non c’è possibilità di scelta.
Chi lavora sì, chi ha una famiglia che può sostenerl3 va bene, chi trova la solidarietà del coabitare, in qualche modo le mestruazioni vengono gestite.
L’obiettivo di “Assorbire il cambiamento” non è mai stato solo quello di donare assorbenti usa e getta o lavabili, come abbiamo detto più volte volevamo incontrare le persone: consegnare il materiale, ascoltare le loro esigenze, costruire insieme dei “laboratori” per parlare di ciclo abbattendo i tabù e presentare – grazie alla collaborazione con Camilla (Laboratorio sostenibile) – quei dispositivi lavabili e riutilizzabili che possono portare vantaggi economici, igienici ed ecologici importanti.
Ora è arrivata la parte che preferisco, quella dell’incontro appunto.
Incontro a Casa di Leda
Mercoledì io e Camilla siamo state a Casa di Leda, vi racconto un po’ com’è andata.
All’inizio, come succede quando guardi per la prima volta visi nuovi, siamo state sommerse dagli sguardi. Sguardi curiosi, diffidenti, infiltranti. Sono ormai due anni che percepisco quegli sguardi penetranti e non credo di saper spiegare bene cosa si provi nel’accoglierli, restano dentro. Cercano di indagarti. Sanno chi rappresenti, vogliono capire chi sei.
Ci accomodiamo in una stanza ricca di giochi per bambin3, c’è una tenda, dei libri, delle sedioline e un grosso tavolo. Con l’operatrice della struttura sistemiamo le sedie: mettersi in semicerchio è sempre una buona idea per guardarci in faccia e continuare quel gioco di sguardi. Arrivano una alla volta le donne di Casa di Leda e una bambina che ha da poco esperito il suo primo menarca. Questo forse, pensiamo con Camilla, lo renderà ancora più importante per qualcuno. Io da piccola mica ho avuto la possibilità di stare in una stanza a parlare di ciclo con sconosciute! Superato l’imbarazzo, sarà sicuramente interessante. O almeno questa è la speranza.
Ci presentiamo, iniziamo a parlare e come sempre accade quando si ha un’idea, una “scaletta” di argomenti da trattare, la curiosità del momento ha spostato tutte le attenzioni sulla bustina blu di stoffa contenente gli assorbenti lavabili di Laboratorio sostenibile.

Così Camilla ha iniziato a spiegare come sono fatti, quando e come vanno lavati, quanto possono durare, diciamo tutte quelle informazioni di cui abbiamo scritto qualche articolo fa: “Le mutande assorbenti e il carcere”.
Diventa subito facile parlare di qualcosa che va oltre i confini delle nazionalità, delle appartenenze culturali, dei differenti gruppi sociali, quando si condivide nell’immediatezza dei corpi la ciclicità fisiologica del sanguinare.
Assorbire il cambiamento – gli assorbenti lavabili in carcere è una soluzione possibile?
Nonostante l’entusiamo ricevuto per gli assorbenti lavabili – se non da tutte almeno da 4 persone su 5 – alla domanda “In carcere può funzionare secondo voi?”, la risposta è arrivata all’unisono: no! Si è ragionato come anche negli altri incontri, sulla questione economico-logistica, per cui sarebbe certo una soluzione a lungo termine del problema quella di avere a disposizione sempre i propri assorbenti lavabili (che durano in media 5 anni!). Cosa non può funzionare? Il lavaggio e l’asciugatura.
«Non si asciuga manco ‘na maglia, figurate questo che è doppio» ha detto S.
«10 anni fa si potevano mette fuori i panni adesso no» ha continuato G.
Mentre spiegavo meglio il progetto di Assorbire il cambiamento sono stata interrotta al “la maggior parte degli assorbenti li portiamo in carcere…”.
«E fate bene, veramente, perché ce n’è bisogno in carcere» ha affermato E, mentre le altre annuivano e confermavano quel che cerchiamo di far emergere da mesi.
Perché secondo le loro esperienze, in linea con le altre già raccolte di Maria, Rosaria e Sonia, gli assorbenti in carcere non arrivano sempre e quando arrivano sono pochi. Pensiamo di vivere il nostro ciclo con un pacco al mese, con tre rotoli di cartigienica e senza bidet! E ci ha raccontato che quando è entrata aveva le mestruazioni, non aveva assorbenti con sé e ha dovuto arrangiarsi.
«Ho preso il lenzuolo e l’ho strappato poi ho fatto così e via» – mimando il posizionamento del lenzuolo tra le gambe. Ti tieni gli assorbenti fino a quando reggono, anche l’estate quando il materiale, con il sudore e il sangue in eccesso irrita la pelle. Devi farlo per usarne il meno possibile. Certo che se ti finiscono puoi sempre chiedere a chi ne ha di più, l’altra sa che la prossima volta avrà un assorbente da te; alcune magari li vendono ma «Devi essere proprio str**za per vendere l’assorbente a un’altra mamma» ha concluso E.
Sul bidet la questione è sempre la stessa, diverse le carceri, diverse le sezioni, diverse le disponibilità. Quindi in alcune è presente, in altre no.
D ha spiegato: «Nel carcere di *** alla sezione con i figli, dove c’è l’asilo tutto, c’è il bagno in camera e hai tutto, nell’altra ci sono le docce tutte insieme».
G ha poi commentato ridendo «Tanto la metà non si lava quindi non è un problema».