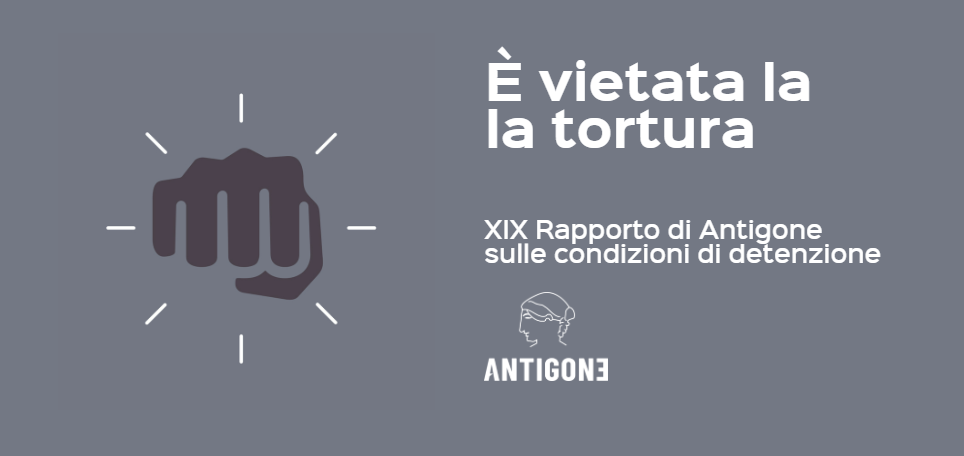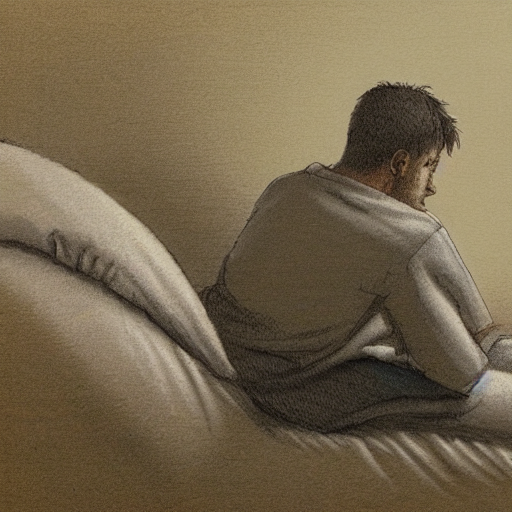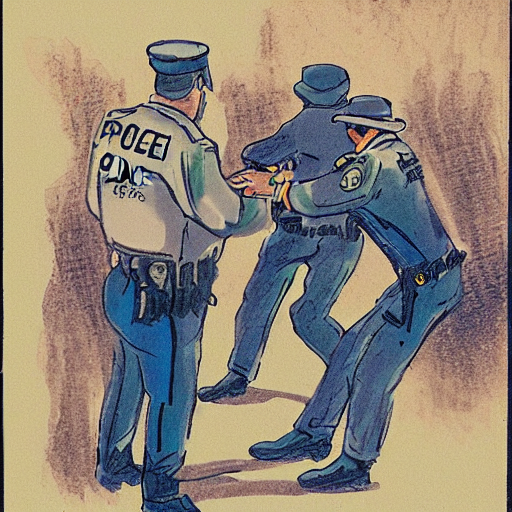LE PAROLE DI C
Vorrei parlare del 41bis che nasce come una misura emergenziale nell’estate del 1992 per contrastare gli attentati mafiosi nei confronti dello Stato italiano e fu emanato decreto emergenziale e introdotto nel codice penitenziario, motivato dall’emergenza del momento.
Nell’estate del 2008 il decreto emergenziale è stato tramutato in Legge dello Stato.
Quindi cos’è il 41bis?
Le persone che al loro arresto vengono sottoposte a tale regime carcerario subiscono misure restrittive che quotidianamente vanno al di là del confine tra il lecito e l’illecito, superando i limiti della Costituzione italiana.
Il 41 bis nasce per controllare le comunicazioni di una minima parte di detenuti, circa 750.
All’interno di ogni carcere che dispone di una sezione 41 bis, c’è una zona che si chiama area riservata, dove vengono ristretti quelli che vengono ritenuti i capi mafia, come per esempio Raffaele Cutolo o Totò Riina.
Controllo della comunicazione del detenuto sottoposto al 41bis
Gli unici modi che il detenuto ha per comunicare sono il colloquio e le lettere.
Attraverso il colloquio di 1 ora ogni mese, quindi 12 colloqui l’anno, il detenuto può parlare con la propria famiglia da dietro un vetro blindato. Il detenuto che ha un figlio può vederlo senza vetro: viene chiuso in una stanza con il bambino, dopo essere stato perquisito a fondo, questo per i bambini fino a 12 anni ma possono stare solo 10 minuti.
Ogni incontro è registrato, non è possibile neanche fare gesti, perché potrebbero essere segnali per ad esempio ordinare un colpo.
Poi si può scrivere alla propria famiglia e alle persone libere ma è vietato avere corrispondenza con altri detenuti.
Ogni lettera da inviare va consegnata aperta perché la posta è sottoposta a censura: per esempio, a volte, io usavo scrivere proverbi e modi di dire… se l’agente che era preposto alla censura nel leggere la mia lettera notava un linguaggio criptico, la lettera veniva sequestrata e inviata al Magistrato di sorveglianza.
Il detenuto di quella lettera non saprà più nulla.
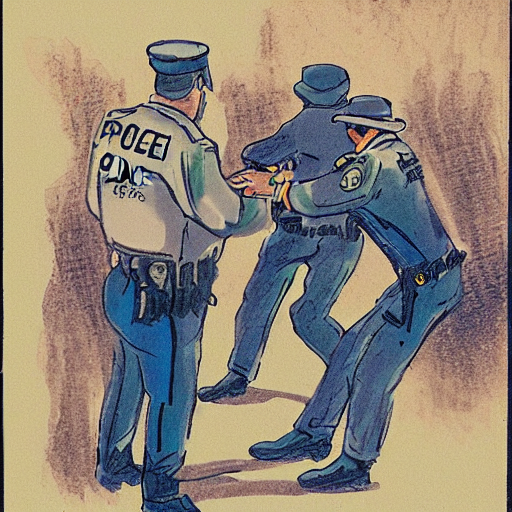
La mia esperienza personale
Durante la mia detenzione al 41 bis durata 11 anni fu discusso diverse volte se prorogare o revocare la misura. L’applicazione regime differenziato mi fu revocata: durante l’udienza il Pm fece riferimento a tutte le sanzioni disciplinari ricevute da me tra cui alcune denunce, ma il Giudice rispose: «Va bene procuratore, sappiamo come vengono trattati i detenuti nei reparti 41 bis, quindi andiamo avanti non soffermiamoci su questo punto, giusto?»
Quindi in quel momento compresi che i giudici sono a conoscenza della realtà che si vive dentro. Non che cambiasse qualcosa, ma è stato importante sapere per certo che un Presidente di un tribunale durante l’udienza dove si discuteva se rinnovare o revocare un provvedimento di regime differenziato, fosse consapevole di come sono trattati i detenuti al 41bis, infatti mi fu revocato.
È vero forse che il 41 bis serve a controllare la comunicazione dei detenuti, almeno quella piccola parte, ma il resto di quelle regole del regime differenziato sono solo abusi volti a distruggere l’identità di una persona. Ad esempio, cosa c’entra l’imposizione degli indumenti intimi, delle calzature, del vestiario con la sicurezza?
Attraverso il racconto di alcuni episodi vissuti, C spiega le particolari condizioni in cui il detenuto del 41bis vive la propria reclusione. Alcune misure possono risultare assurde e prive di significato, altre sembrano invece costruite appositamente per umiliare e spaventare la persona detenuta.
Al detenuto sottoposto a tale regime è stato quasi sempre vietato cucinare per motivi di sicurezza. Ci sono poi molte altre misure, come per esempio ogni volta che uscivo dalla cella dove ero ubicato dovevo sottopormi – come tutti gli altri detenuti – ad una perquisizione, che comprendeva denudazione e altre umiliazioni come fare flessioni e essere perquisito ovunque, perfino in bocca.
Quando devi parlare con il comandante, due o tre agenti ti scortano in ufficio, mentre dentro ad aspettarti ce ne sono degli altri. Una volta entrato, subito ti fanno fare due passi avanti perché devono entrare tutti, con gli agenti dietro le spalle ti ordinano di mettere le mani dietro la schiena. Mentre parli con il comandante sei consapevole di avere dietro di te altre quattro, cinque o sei persone che solo con la loro presenza incutono un senso di timore perché il detenuto in quelle situazioni è sempre in stato di minorità e al minimo errore può subire conseguenze, anche aggressive.
C riflette sul comportamento di alcuni degli agenti che ha incontrato durante il suo percorso, è questo il modo giusto di relazionarsi con il detenuto?
Allora quando succede questo, penso che loro non stanno lì per fare gli agenti ma per fare qualcos’altro. Chi ti autorizza a comportarti in questo modo? Cosa ti ho fatto?
Ho commesso dei reati gravi? Sì, infatti sto in carcere.
Stare in carcere significa che si deve essere trattati da detenuti non che si debbano ricevere aggressioni o torture psicologiche.
Mi privi dell’aria, mi privi di guardare il cielo, mi privi di un affetto, mi privi anche della gioia: è proprio così, per un ragazzo di ventiquattro o venticinque anni che dalla sera alla mattina si trova chiuso in quel regime.
E ricorda di quando è stato arrestato, le sensazioni che ha provato: oltre la paura, lo smarrimento di non conoscere il tempo della sua pena nel regime differenziato.
Io personalmente non è che non ho avuto paura, dico la verità, quando mi hanno caricato sull’aereo per portarmi al 41bis, sapevo che esisteva chiaramente ma non ci ero mai stato. Non è che ho pianto ma dentro di me avevo un po’ di timore.
Quando sono stato arrestato, si è deciso che fossi pericoloso e quindi dovevo andare al 41bis ma neanche mi hanno detto per quanti anni ci sarei dovuto stare.
È tutto senza regole. Mi danno il 41bis, prendo l’aereo e vado. All’epoca si discuteva ogni 6 mesi, cioè ogni 6 mesi in tribunale si discuteva la tua pratica: mi davano sempre 2 ore di colloquio al mese e 2 pacchi (con i vestiti e le cose che i miei famigliari potevano inviarmi). Poi hanno fatto un tribunale speciale per discutere il 41bis.
Il caso Cospito e l’abolizione del 41bis
Il caso Cospito secondo me è una battaglia persa perché è diventato uno strumento di propaganda politica (caso Donzelli).
Il 41bis non lo aboliranno mai, al massimo cambieranno delle minime cose interne per dare il contentino a chi non è d’accordo con questo tipo di regime.
Ad esempio abolendo alcuni divieti che riguardano l’alimentazione e tutti i generi che i detenuti del 41bis per circolare interna non possono avere.
Alla fine di tutto, penso che se il caso Cospito andrà così a fondo da portare il brigante o il politico di turno a entrare nel merito del regime, potrà al massimo “addolcire” internamente i detenuti e aumentare magari i colloqui con gli affetti e queste cose qua.

Per argomentare il suo discorso, C fa riferimento alle parole dell’ex magistrato e presidente della Commissione antimafia Luciano Violante in relazione ai detenuti mafiosi reclusi al 41 bis. Poi, esprime brevemente il suo pensiero riguardo alla mafia in generale e al sistema rieducativo del carcere in Italia, sempre riferendosi alla propria esperienza di vita.
Io penso seriamente che pure il più spietato dei capi invecchia, dopo 40 anni di detenzione. Violante, che secondo me è un uomo che ha detto sempre la verità, ha affermato che i vecchi devono morire e i giovani devono farsi vecchi in carcere.
I mafiosi sono il male dell’Italia, sono d’accordo, stanno bene dove stanno però trattateli da umani. Fateci vedere che lo Stato è meglio di loro. Perché io delinquente che mi alzo la mattina e vado a vendere la droga, vado a fare le estorsioni, sono una persona deviata. Posso essere recuperato o meno, è una scelta che devo fare. Se io mi recupero, devo far vedere agli “ex compagni miei” come sto meglio, spensierato che non ho più tutte le preoccupazioni che hanno loro, non devo più stare sempre attento a guardarmi le spalle per paura che in ogni momento possano uccidermi. Perché quello che fai ti viene fatto, non è che c’è tanta alternativa.
Nel mio caso, credetemi, io avrei avuto bisogno tanto di educatori o psicologi. Sono sempre stato solo e in ogni colloquio che ho fatto non sono mai stato seguito veramente.
Allora mi sono reso conto che è proprio la struttura che non è fatta per farti recuperare, quindi che lo Stato non ti vuole recuperare. Io oggi sono qui, lo devo dire, per la mia famiglia che mi dà sostegno. Le altre persone come me? Ne conosco molti che hanno perso anche le mogli, perché nessuna donna s’imbarca dentro una storia del genere e se tu le vuoi bene le dici di non venire più a trovarti. Restano abbandonati, dalle famiglie e da chi li dovrebbe aiutare. Non c’è speranza, per questo dico che non ci credo.
E lo dico io perché so molto bene la fortuna che ho avuto e continuo ad avere.