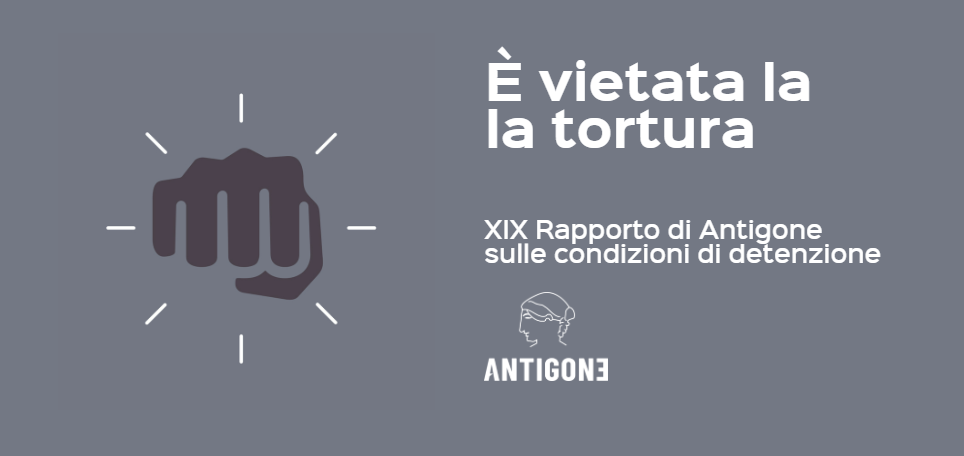L’esperienza detentiva di Domenico torna oggi a raccontarci di un’amicizia stretta dentro, una tra le molte, che continua ancora adesso nel segno di una solidarietà costruita sulle ingiustizie vissute da chi oltre a non essere libero e legale, non è neanche “italiano”.
DOMENICO
Il carcere. Il carcere non fa bene. Fa male a tutti, a tanti fa incattivire. A me non mi ha fatto mai incattivire. Nonostante i tanti anni passati dentro, non è mai riuscito a mettermi la cattiveria, il veleno, niente.
Non ho mai fatto reati ostativi lesivi, risse, accoltellamenti, no mai. Mai perchè ho sempre cercato di evitarli, sono sempre stato amico con tutti. Ancora oggi ho amici in carcere a cui scrivo che me rispondono. Capisci?
L’incontro con il diverso da sé nell’esperienza detentiva
Di regola, dopo due mesi ti danno la cella “a solo”. Dove stavo io c’era un ragazzo del Senegal che erano 10 mesi che stava nel “cellone” – una cella chiamata così perché è dove si concentra un alto numero di presenza, circa 5 o 6 persone – questo faceva il Ramadan e tutto quanto. Un giorno io gli chiedo “Perché te stai sempre qua?”.
“Io vado dal comandante e il comandante eeh”. E io gli ho detto “‘Namo dal comandante, viè”.
Lì al penale bussi e te apre, se ce sta, il capo posto. Sono andato dal capo posto è gli ho detto “Senti ce sta sto ragazzo qui, so 10 mesi… so 10 mesi che sta nel cellone. So 10 mesi che sta lì… Allora lì fumano e lui non fuma, deve fare il Ramadan eeee è ‘n casino, poro fijo. Ma scusa eh!” E sono dovuto andare a parlarci io.
Il capo posto mi risponde: “Ma tu sei l’avvocato suo?”.
“No, non so’ l’avvocato suo ma non pare giusto che qui la gente entra e lo scavalcano, entra e lo scavalcano. Ma perché? Perché è scuro?” – gli ho detto – “Non è calcolato, non è giusto”.
E il comandante ha detto poi al ragazzo: “Ma perché lei è 10 mesi che sta così?”
Manco lo sapeva! Manco lo sapeva. Poi all’ultimo gli hanno dato la cella a solo. A 3 mesi dal fine pena perché era stato condannato perché dice che era scafista ma lui me l’ha spiegato a me. “Io non ero scafista, io ho portato il motoscafo ma m’hanno pagato il viaggio sennò manco potevo venì” – mi ha detto – “Mica io ho frustato a qualcuno o ho fatto male a qualcuno, siamo arrivati lì e poi me ne so andato tutto qui e m’hanno dato 3 anni”. Quello è, ma è un bravo ragazzo.
Ora sta a Roma io ho il numero di telefono, siamo rimasti in contatto. Quando è uscito è venuto a pranzo da me, siamo stati insieme pure con il fratello. Lavora sempre, dalla mattina alla sera, pure la domenica, pure i giorni festivi.
Dal carcere ai CPR
Io pure sta cosa che gli extracomunitari una volta usciti li portano nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), ossia li ri-carcerano un’altra volta, non la capisco! Si fanno una doppia esperienza detentiva.
Dopo che hanno pagato quello che dovevano paga con la giustizia, li ri-carcerano n’altra volta poracci. Capito?
E non è giusta sta cosa, è proprio sbagliata! Hanno già pagato! Io che ne so, devono aspettare mesi, mesi, mesi per che fare poi? Pe pote’ esse imbarcati al paese loro? E non va bene. Purtroppo, queste persone scappano perché hanno fame o per le guerre, le cose… Vengono qui fanno i danni, nel senso che fanno i danni perché non hanno niente, parlamose chiaro. E che fanno una volta che commettono i reati? Li cacciano, pagano il reato che hanno fatto e li portano ai CPR, li fanno sta ancora lì dentro… è brutta sta cosa eh. Come se io , che ne so, esco dalla galera e invece di mandarmi a casa me mandano da un’altra parte. Eh, non va bene.
La criminalizzazione del migrante si estende negli ultimi anni e sempre con maggiore ferocia anche all’atto stesso del migrare, come abbiamo potuto già osservare durante la Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2023. Nella sezione dedicata, andiamo a leggere le particolarità di un fenomeno che vuole nell’immaginario sociale la persona straniera come persona pericolosa, così diversa e lontana per “cultura” o “etnia” che non può conoscere né comprendere “le regole di casa nostra”. Alla banalizzazione assoluta di termini complessi – rappresentanti persone, vite e storie reali – che spesso accompagnano i discorsi del quotidiano, rispondiamo con le analisi, le ricerche sociali e le statistiche raccolte nel Dossier riguardo ai processi di criminalizzazione del migrante, di categorizzazione sociale e di securitarizzazione dello straniero. Ripercorriamo insieme i punti fondamentali affrontati qui.