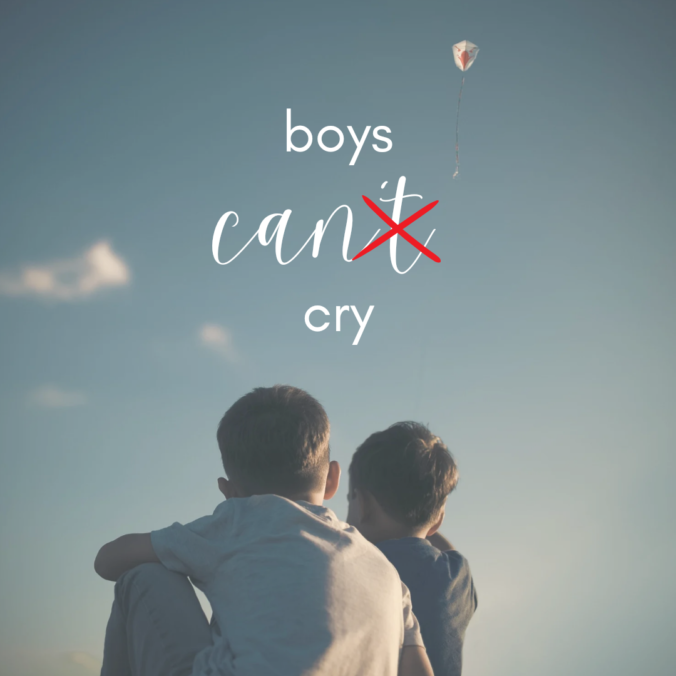Il 13 febbraio dello scorso anno abbiamo pubblicato “ufficialmente” questo blog. Dopo mesi di preparazione, di aspettative, di negoziazioni si è detto a un certo punto: «Ok, puoi andare».
Passo dopo Passo è nato con tanti obiettivi, tante speranze e prospettive che in un anno non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Se inizialmente abbiamo dato quasi un taglio diaristico, con le voci delle persone detenute all’interno delle strutture di accoglienza gestite della cooperativa PID Onlus, con il tempo si sono aggiunti punti di vista e penne critiche che hanno determinato quel che a me piace chiamare “la rubrica del ricercatore spossato”. C’è chi scrive delle proprie esperienze di dentro, chi decide di dire la sua su un fatto di cronaca, chi vuole raccontare il proprio lavoro, chi ancora riorganizza tutte queste informazioni con la speranza di aprire riflessioni più ampie. Abbiamo utilizzato e continueremo a utilizzare questo blog per dire dei progetti o per informare sulle questioni del carcere in Italia. Scorrendo tutti i 60 articoli prodotti fin qui cresce dentro un senso di soddisfazione generativa che dà risposta alla domanda che tante volte mi sono ritrovata a pormi: «perché lo fai?». Per non parlare del fatto che mi è quasi impossibile selezionare “articoli preferiti”, tutti sono unici a loro modo per il semplice motivo per cui sono stati scritti.
È travolgente la micro realtà in cui ti immergi.
Così l’abbracci.
Esseri umani: questa la parola che più ho sentito pronunciare durante le mie chiacchierate con le persone seguite dal PID.
Esseri umani in quanto partecipi del rapporto tra individui, persone.
Le dinamiche che si intrattengono in Carcere, l’immediatezza dei ruoli, la consapevolezza sbiadita: fuggevole, attrice, di protesta e sostanziosa – la voce che racconta la complessità della vita.
Questa la realtà, il motivo della nascita di Passo dopo Passo sorge spontaneo.
A un anno dalla nascita del blog abbiamo vissuto avventure di ogni tipo, dall’organizzazione dell’evento celebrativo del nostro lavoro come cooperativa-famiglia, ai primi passi oltre i cancelli del carcere. Ho avuto la fortuna di vedere le persone uscire, ricostruire nuove libertà e nuove opportunità, ho ascoltato la pienezza delle parole «ho finito, non ho più nulla da pagare, ho pagato tutto». Le persone hanno attraversato la casa famiglia, l’hanno vissuta imprimendo la propria traccia sui balconi colorati di un semplice appartamento romano, raccontando parte della loro storia al mio registratore e lasciando che quella storia arrivasse a voi, su questo blog. Un po’ custode di qualcosa che doveva essere detto, che voleva essere narrato.
Ogni settimana, da quando abbiamo aperto il blog, mi metto a pensare a cosa pubblicare. Non è semplice perché vorrei scrivere robe super “accademiche”, dimenticando che l’obiettivo iniziale era far parlare chi il carcere l’ha vissuto (e magari lo vive ancora). Da quando ho incontrato O, nonostante le difficoltà iniziali, nonostante ancora oggi a volte la comunicazione sia tutt’altro che semplice, il giovedì ricevo puntualmente articoli di innegabile coinvolgimento emotivo. Mi ricorda perché non posso smettere anche se a leggerci siete in pochi, perché mi piace quello che ho scelto di fare, perché ho “bisogno” di continuare a formarmi.
Quanto è bella la voglia di condividere la propria voce anche quando nessuno l’ascolta o anche quando magari non riceve prontamente risposta.
A un anno dalla nascita del blog abbiamo visto il mondo chiudersi lentamente e con ferocia, abbiamo sentito stringere il nodo alla gola, la paura che professionalità, dedizione e pazienza non sarebbero più bastati a svolgere al meglio il nostro lavoro. Che le persone detenute, un po’ di più di tutte le altre, non avrebbero neanche più avuto quei pochi diritti che faticano a stringere nelle mani. E tutto sempre con la consapevolezza di quanto sia semplice essere fraintesi quando si parla di carcere, di detenzione, di persone che hanno leso altre persone o le loro proprietà. Ho scritto già da qualche parte che «Quando ci si ritrova in questi discorsi, il rischio è sempre quello di sembrare i grandi giustificatori degli atti criminali, in fondo quel che si cerca qui di sostenere è che il confine tra quel che si considera giusto e quel che si considera sbagliato è troppo labile per perderci in generalizzazioni di questo tipo».
Questa è la società che abbiamo, durante questi lunghi e complessi secoli, costruito. Riconosco a volte con amarezza e disillusione che il desiderio di un mondo più giusto e sicuramente più umano nel pieno senso della parola è una visione utopistica. Forse lo è sempre stata, forse lo sarà sempre. Sono sistemi complessi che hanno un’altrettanto complessa moltitudine di “ragioni”. Non possiamo negare che figli e figlie della nostra cultura siamo costantemente incazzate e incazzati, senza sapere precisamente il perché. Tutto è così confuso.
Siamo complici nel guardare un mondo di conflitti, nel vomitevole impigliarsi di una storia feticista. E noi nel nostro piccolo, con il nostro lavoro e il nostro blog cerchiamo di non esserlo. Le domande restano aperte, continuiamo a leggere e a formarci. Continuiamo a sederci su quel divano rosso e ascoltare chiunque in un modo o nell’altro ha esperito la violenza di fuori e di dentro.
Qual è il confine tra la violenza legittima e illegittima?
Sono questi discorsi che lasceremo aperti per altri momenti di riflessione, più approfondita forse, meno pessimista. Ricomponiamoci gli animi per gioire anche un poco di tutto il lavoro svolto fino a oggi e di tutto quello che abbiamo davanti.
A un anno dalla nascita del blog, sono molto grata per tutte le persone che hanno scritto qui, per tutte quelle che hanno letto e leggeranno le nostre parole.